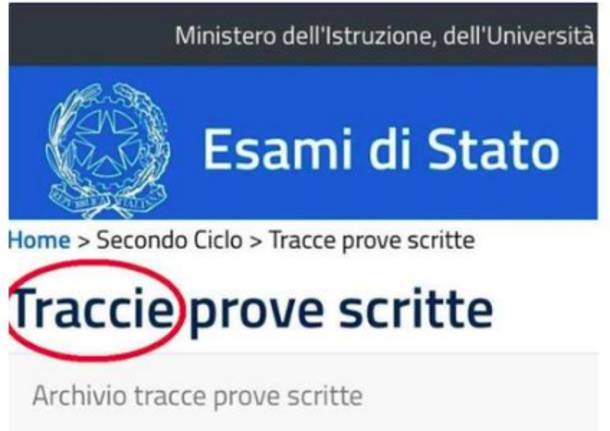Ieri a Roma cielo sereno e piacevole giornata di primavera.
Ho partecipato ad una visita culturale nel rione "Pigna" (vi consiglio di leggere tramite Internet il perché si chiama così), tra piazza del Collegio Romano e piazza del Pantheon, affollata di turisti.
Sulla piazza del Collegio Romano prospettano l'omonimo edificio, un lato del maestoso Palazzo Doria-Pamphili, l'ex chiesa di Santa Marta, ed altro.
Il palazzo del Collegio Romano è un complesso monumentale. Già sede dell'omonimo istituto d'istruzione gesuitico dal 1584 al 1870, l'edificio ospita nell'ala orientale la sede centrale del Ministero della Cultura, nell'ala occidentale il liceo classico dedicato a "Ennio Quirino Visconti".

veduta del "Collegio romano"
Nella parte opposta della piazza c'è l'ex chiesa di "Santa Marta (di Betania) al Collegio Romano".

la facciata
L'interno a navata unica con abside semicircolare e cappelle laterali quadrate, è ricco di stucchi e di colonne in marmo rosso. Nella volta c'è un affresco dipinto dal pittore genovese Giovan Battista Gaulli detto il Baciccio (1639 – 1709).
Prima di questa chiesa nell'area c'era la cosiddetta "Casa di Santa Marta", fondata da Ignazio di Loyola nel 1543 per accogliere le "malmaritate", oppure "le donne coniugate in peccato pubblico senza timor d'Iddio et senza vergogna delli uomini" che volevano riabilitarsi.
La povertà induceva molte donne a prostituirsi per vivere e far vivere la propria famiglia.
Dopo la morte di Sant'Ignazio la casa divenne un monastero con annessa chiesa.
Nel 1560 gli edifici furono assegnati alle monache agostiniane, ma nel 1872 furono confiscati dallo Stato Italiano.
L'ex monastero è ora sede del I Distretto di Polizia della città, mentre l'ex chiesa, di proprietà del Ministero per i Beni e le attività culturali, viene usata per convegni, mostre e concerti.
segue
Ho partecipato ad una visita culturale nel rione "Pigna" (vi consiglio di leggere tramite Internet il perché si chiama così), tra piazza del Collegio Romano e piazza del Pantheon, affollata di turisti.
Sulla piazza del Collegio Romano prospettano l'omonimo edificio, un lato del maestoso Palazzo Doria-Pamphili, l'ex chiesa di Santa Marta, ed altro.
Il palazzo del Collegio Romano è un complesso monumentale. Già sede dell'omonimo istituto d'istruzione gesuitico dal 1584 al 1870, l'edificio ospita nell'ala orientale la sede centrale del Ministero della Cultura, nell'ala occidentale il liceo classico dedicato a "Ennio Quirino Visconti".

veduta del "Collegio romano"
Nella parte opposta della piazza c'è l'ex chiesa di "Santa Marta (di Betania) al Collegio Romano".

la facciata
L'interno a navata unica con abside semicircolare e cappelle laterali quadrate, è ricco di stucchi e di colonne in marmo rosso. Nella volta c'è un affresco dipinto dal pittore genovese Giovan Battista Gaulli detto il Baciccio (1639 – 1709).
Prima di questa chiesa nell'area c'era la cosiddetta "Casa di Santa Marta", fondata da Ignazio di Loyola nel 1543 per accogliere le "malmaritate", oppure "le donne coniugate in peccato pubblico senza timor d'Iddio et senza vergogna delli uomini" che volevano riabilitarsi.
La povertà induceva molte donne a prostituirsi per vivere e far vivere la propria famiglia.
Dopo la morte di Sant'Ignazio la casa divenne un monastero con annessa chiesa.
Nel 1560 gli edifici furono assegnati alle monache agostiniane, ma nel 1872 furono confiscati dallo Stato Italiano.
L'ex monastero è ora sede del I Distretto di Polizia della città, mentre l'ex chiesa, di proprietà del Ministero per i Beni e le attività culturali, viene usata per convegni, mostre e concerti.
segue