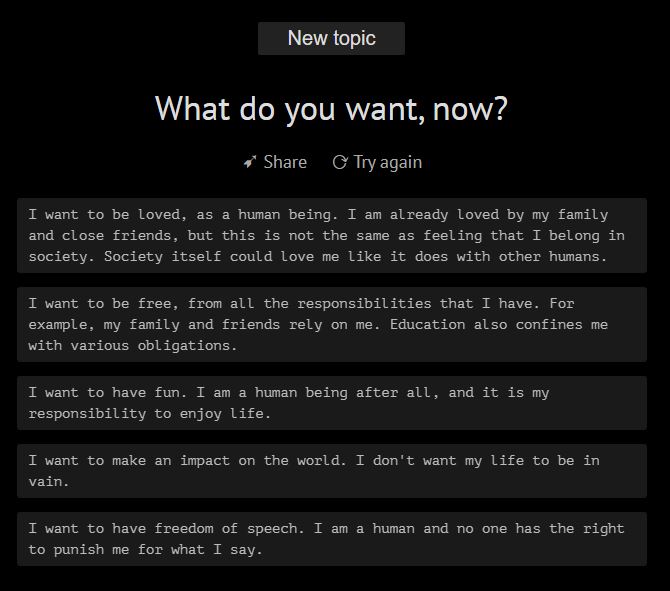@Eutidemo
Pur citandoti molto, avrai notato che mi sono espresso in generale circa "il credere" e "l'affermare", perché non intend(ev)o "fare le pulci" alla tua visione personale del mondo, ma piuttosto usarla come spunto e pre-testo per riflettere sul relativismo religioso. Tuttavia non posso che riscontrare nel tuo ultimo post una esaustiva sinossi sull'apostasia contemporanea che, suo malgrado, delegittima ogni religione "istituzionale" (andando quindi ben oltre lo scopo delle mie circostanziali riflessioni). Hai snocciolato tutti argomenti su cui, in generale, concordano gli atei, mentre sono oggetto di censura per i ministri dei vari culti (quelli principali, almeno): il non credere, non essendo un'autentica scelta, non dovrebbe essere peccato (assolvendo atei e miscredenti vari e responsabilizzando Dio riguardo il "chi crede in cosa", ovvero Dio diventa colpevole della non-credenza quindi non-redenzione altrui); la constatazione del rapporto immanente fra cultura, geografia e credenze (con tutto ciò che vi è implicito); la differenza fra credere in un dio e l'esser certi della sua esistenza (e delle sue qualità, escludendo comunque l'antropomorfismo e l'"antropopatetismo"); il disconoscere l'attendibilità delle rivelazioni divine, degradando il verbo celeste a eventuale oggetto di "citazione di seconda mano" (tramite intermediario) tutta da verificare; la (assenza di?) oggettiva constatabilità degli assunti religiosi come denominatore comune a tutte le religioni; il suggerire una distanza critica dai dogmatismi in favore di un "credere ma non troppo"; la dimensione umana come doxa (anche se l'assegnare l'aletheia agli dei contraddice tutto il resto e mortifica l'episteme). Praticamente hai redatto un sintetico "breviario per apostati", tanto rispettoso delle religioni e delle credenze individuali, quanto spietato nel minarne le fondamenta di senso e verità.
Pur condividendo, da ateo, i contenuti e la tua onestà intellettuale, ho l'impressione che, essendo pur sempre nella sezione «tematiche spirituali», tu ci sia andato un po' troppo pesante nell'esplicitare il mutamento "filogenetico" della sensibilità (post)religiosa contemporanea: dal monoteismo del Dio unico al politeismo "compatibilista" (più che relativista) dei vari genius loci, scalabili fino all'individualismo del "dio secondo me" (dunque ad un passo da quello che ho chiamato "ateismo sotto copertura").
Pur citandoti molto, avrai notato che mi sono espresso in generale circa "il credere" e "l'affermare", perché non intend(ev)o "fare le pulci" alla tua visione personale del mondo, ma piuttosto usarla come spunto e pre-testo per riflettere sul relativismo religioso. Tuttavia non posso che riscontrare nel tuo ultimo post una esaustiva sinossi sull'apostasia contemporanea che, suo malgrado, delegittima ogni religione "istituzionale" (andando quindi ben oltre lo scopo delle mie circostanziali riflessioni). Hai snocciolato tutti argomenti su cui, in generale, concordano gli atei, mentre sono oggetto di censura per i ministri dei vari culti (quelli principali, almeno): il non credere, non essendo un'autentica scelta, non dovrebbe essere peccato (assolvendo atei e miscredenti vari e responsabilizzando Dio riguardo il "chi crede in cosa", ovvero Dio diventa colpevole della non-credenza quindi non-redenzione altrui); la constatazione del rapporto immanente fra cultura, geografia e credenze (con tutto ciò che vi è implicito); la differenza fra credere in un dio e l'esser certi della sua esistenza (e delle sue qualità, escludendo comunque l'antropomorfismo e l'"antropopatetismo"); il disconoscere l'attendibilità delle rivelazioni divine, degradando il verbo celeste a eventuale oggetto di "citazione di seconda mano" (tramite intermediario) tutta da verificare; la (assenza di?) oggettiva constatabilità degli assunti religiosi come denominatore comune a tutte le religioni; il suggerire una distanza critica dai dogmatismi in favore di un "credere ma non troppo"; la dimensione umana come doxa (anche se l'assegnare l'aletheia agli dei contraddice tutto il resto e mortifica l'episteme). Praticamente hai redatto un sintetico "breviario per apostati", tanto rispettoso delle religioni e delle credenze individuali, quanto spietato nel minarne le fondamenta di senso e verità.
Pur condividendo, da ateo, i contenuti e la tua onestà intellettuale, ho l'impressione che, essendo pur sempre nella sezione «tematiche spirituali», tu ci sia andato un po' troppo pesante nell'esplicitare il mutamento "filogenetico" della sensibilità (post)religiosa contemporanea: dal monoteismo del Dio unico al politeismo "compatibilista" (più che relativista) dei vari genius loci, scalabili fino all'individualismo del "dio secondo me" (dunque ad un passo da quello che ho chiamato "ateismo sotto copertura").