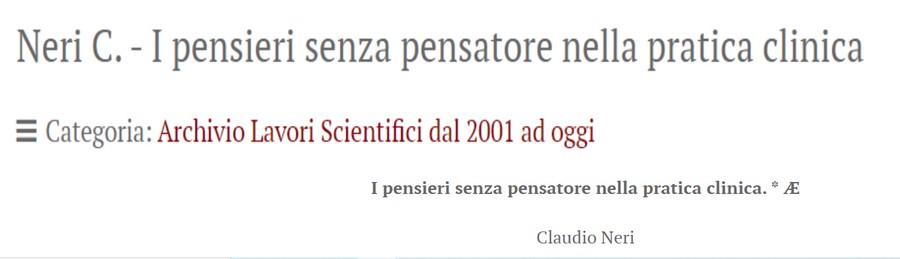Ciao Bobmax 

Anche io penso che:
1 + 1 = 2
5 + 7 = 12
e compagnia bella, siano tutti "giudizi analitici".
***
Però, secondo me, l'1 + 1 = 2 rende tale verità ancora più evidente, in quanto:
- 12 può essere la somma di 5 + 7, di 6 + 6, di 10 + 2 ecc.ecc.
- 2, almeno nell'ambito dei "numeri naturali" (come ho replicato a Phil), non può che essere la somma di 1 + 1.
***
Per il resto condivido tutto quello che hai scritto, in quanto anche io ritengo che il molteplice mondo fenomenico, non sia altro che la manifestazione dell'UNO; il quale, per inciso, è matematicamente contenuto in tutti gli altri numeri (così come l'ESSERE in tutti gli enti)!
***
Un cordiale saluto!
***