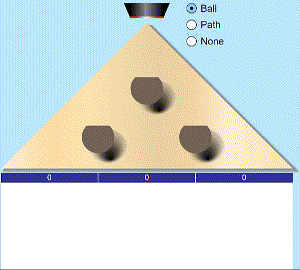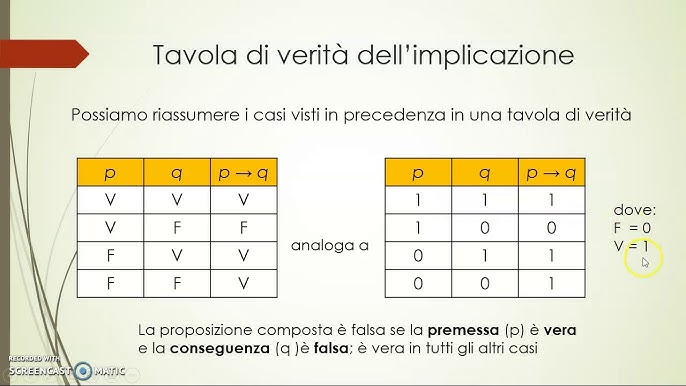Citazione di: anthonyi il 18 Settembre 2024, 17:08:53 PMNaturalmente quella che dietro questi aspetti ci sia Dio, i marziani o pincopallino e questione irrilevante, ciò che è rilevante è che questi aspetti hanno una loro razionalità, ed è proprio questa razionalità che io affermo sia razionalizzabile, cioè spiegabile nella sua razionalità, in contrapposizione alla tua tesi del post 14.La mia tesi è che il presunto agire di Dio non sia razionalizzabile (v. pena infinita per "test" finito, amore e dannazione eterna, etc.); se togliamo Dio dalla discussione e osserviamo che alcune scienze umane spiegano la ratio di come l'"animale sapiens" ha addomesticato il proprio istinto violento, non ho obiezioni in merito, né hanno obiezioni le scienze umane che ho appositamente citato.
Quindi siamo d'accordo: quello che è razionalizzabile non è l'agire di Dio (come da mia tesi), di cui non abbiamo prova, ma il fatto che una certa razionalità abbia emancipato l'uomo, in gran parte, dalla sua dimensione puramente istintiva e violenta. Nell'attesa che Dio, i marziani o pincopallino possano dimostrare di avere un ruolo nella storia e nei mutamenti umani.