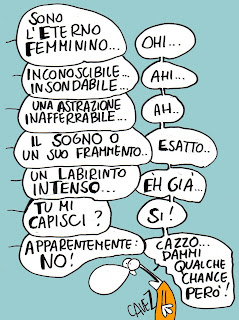Roma, piazza Trilussa, monumento dedicato al poeta romanesco Carlo Alberto Salustri, detto "Trilussa".
Piazza Trilussa è situata tra il Lungotevere della Farnesina ed il Lungotevere Raffaello Sanzio, di fronte a Ponte Sisto, fatto costruire dal pontefice Sisto IV in occasione del giubileo del 1475.
Sulla destra, guardando la foto, c'è l'epigrafe marmorea con incisa la sua ironica poesia titolata "All'ombra"

La traduzione: "Mentre mi leggo il solito giornale sdraiato all'ombra di un pagliaio vedo un porco e gli dico: – Addio, maiale! vedo un asinello e gli dico: – Addio, somaro! Forse queste bestie non mi capiranno ma provo almeno la soddisfazione di poter dire le cose come stanno senza paura di finire in prigione".
Ed ora alcune parole quasi in disuso che incitano un individuo alla violenza verso un altro: sfonnalo, sdrumalo, gonfialo, spaccalo, arompilo, sventralo, aricomponilo.
Parole dialettali ancora in uso:
"a bizzeffe" = in gran quantità;
"a bonbisogno" = all'occorrenza, se serve;
"a bracalone" = chi indossa pantaloni larghi;
"na caterva" = gran quantità;
" a cecio", oppure "a faciolo" = al momento giusto;
" te la fai a fette" = camminare a piedi;
" a pedagna" = camminare a piedi;
" a sbafo" = senza pagare"; per esempio: mangiare senza pagare;
" a scrocco" = a spese di altri.

























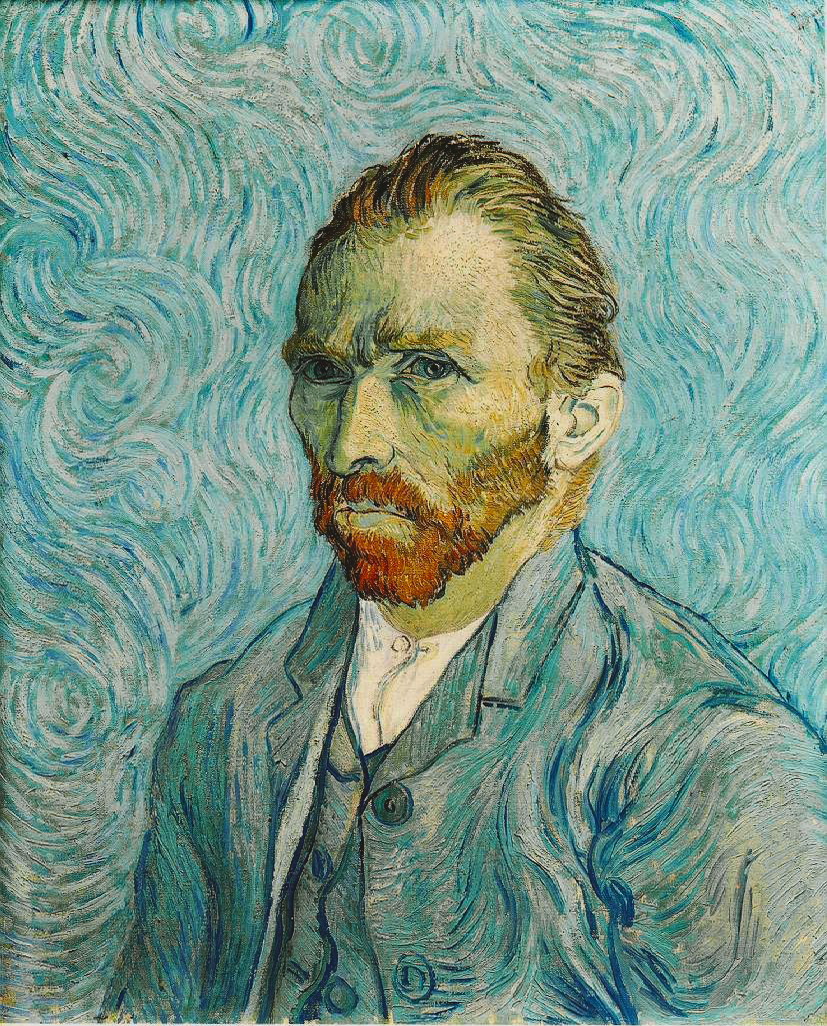
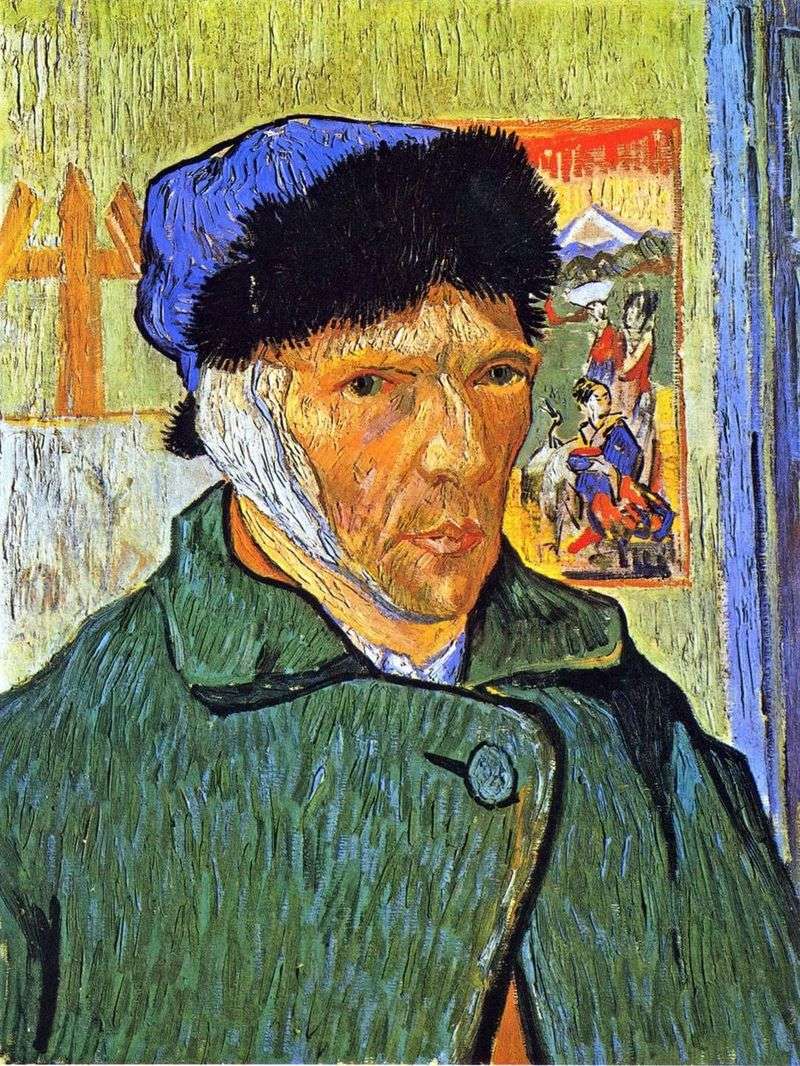




.jpg)