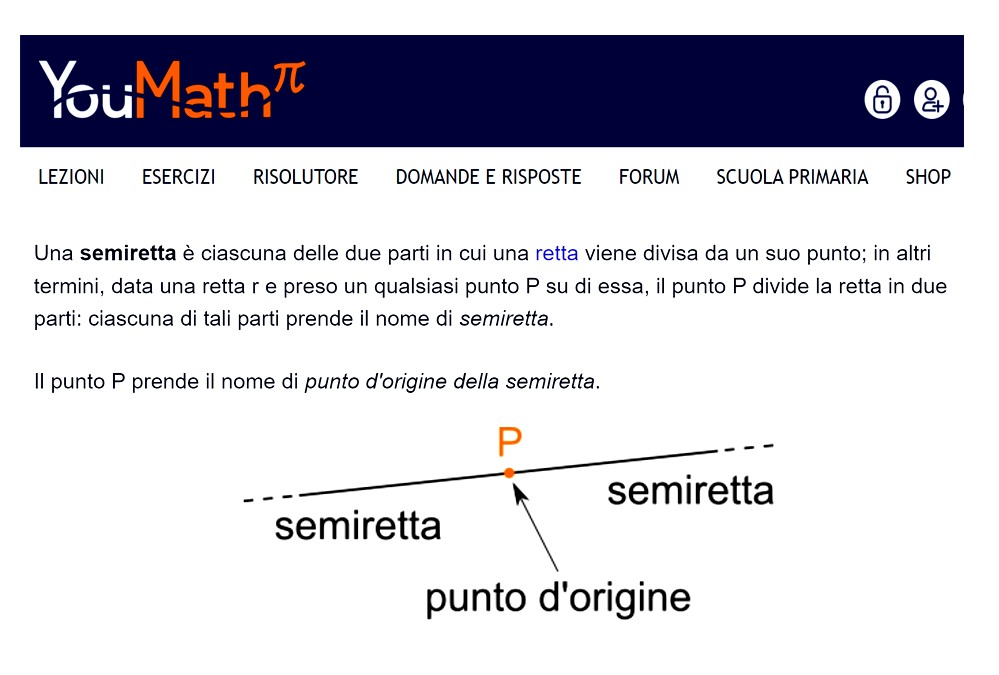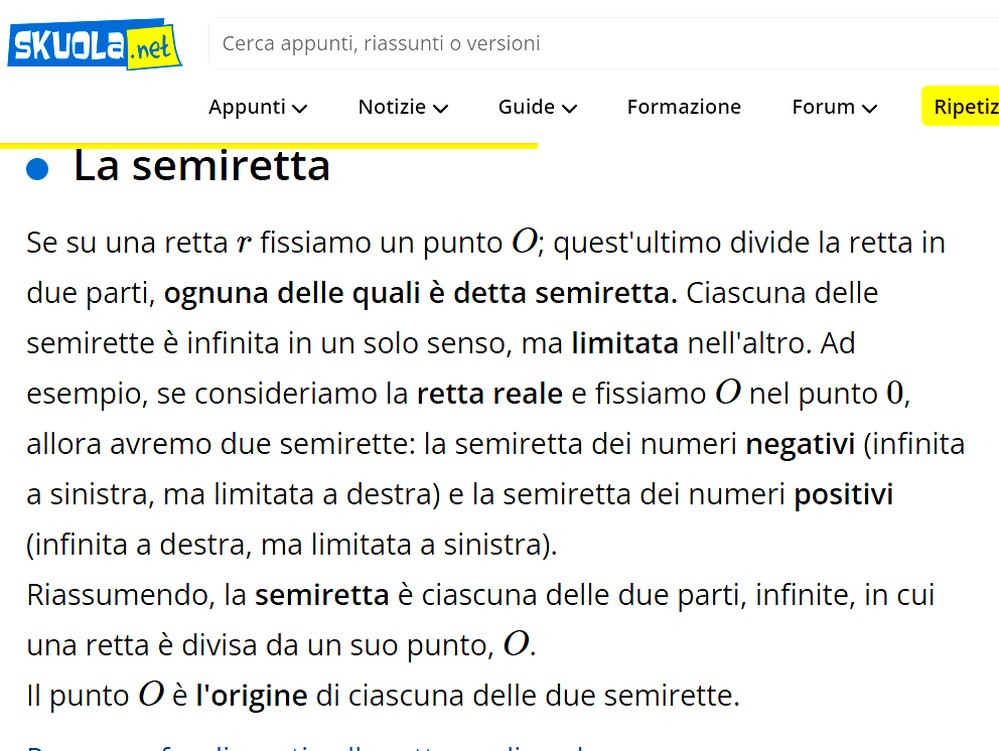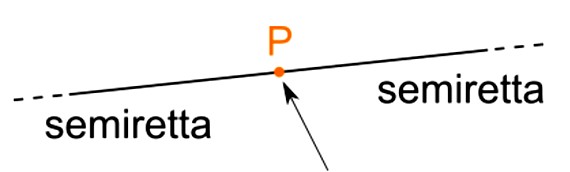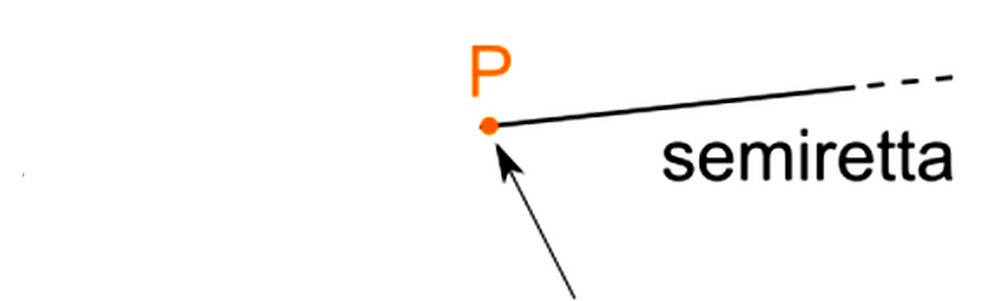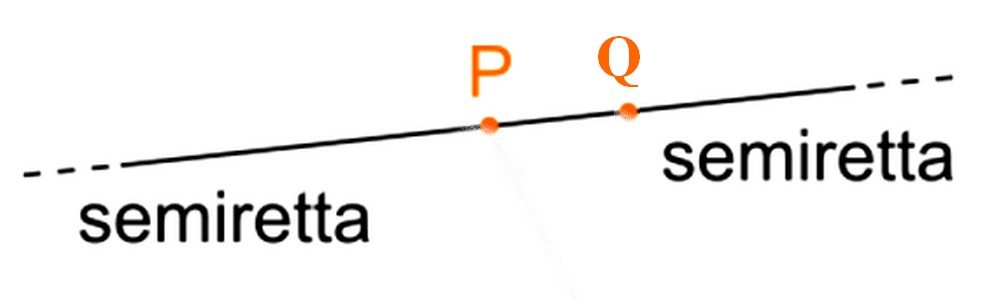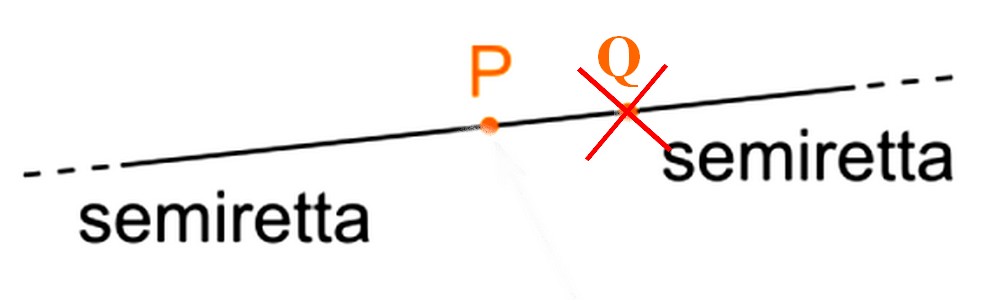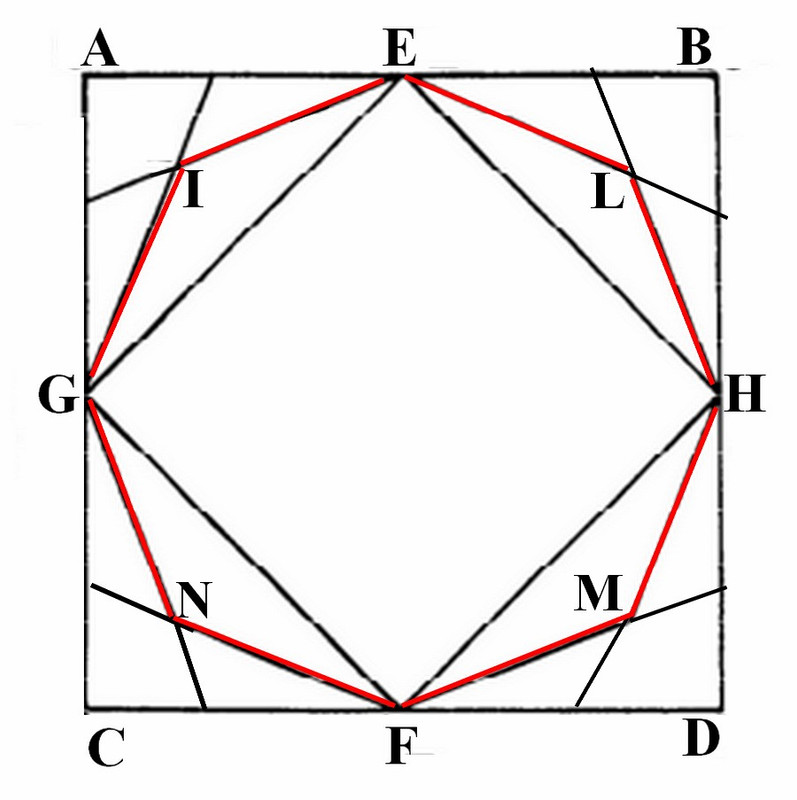Ciao Iano. 

Come io avevo già accennato nel mio topic iniziale, se il padre di Eutifrone era affetto da demenza senile, non sarebbe stato comunque punibile:
- nè ai tempi dell'antica Grecia o dell'antica Roma, perchè per condannare l'imputato era necessario che costui fosse "compos sui" (cioè cosciente di sé e delle proprie azioni);
- nè per il nostro attuale ordinamento giuridico, perchè per condannare l'imputato, è necessario che costui abbia la "capacità di intendere e di volere" (art.85 C.P.).
***
Un cordiale saluto! 

***