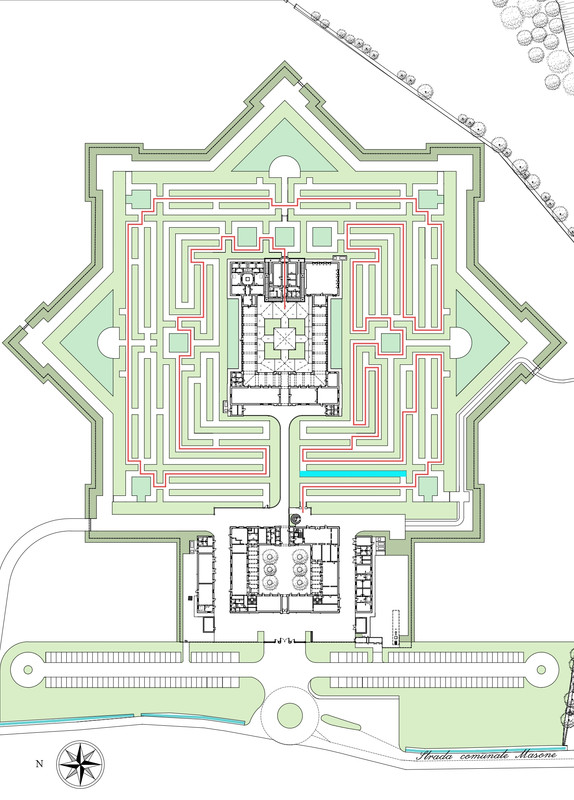La metafora del "tempio" porta con sé altre due metafore che mi pare ne rispettino la pertinenza: la "fede" nel dono (fede per molti, ma non per tutti), e il "sacerdote" del tempio, che ne amministra i riti (figura non priva di responsabilità e dunque da eleggere con accurata circospezione).
C'è poi da considerare che il dono è solitamente figlio del surplus, che in quanto tale presuppone la paternità dell'economia del credito/debito, produzione/commercio, vendita/acquisto (o, ostracizzando il denaro, scambio/resa). Nessuno porta al tempio l'unico maiale che ha (e in una società fatta anche di servizi, oltre che di beni, la metafora si complicherebbe ulteriormente, ma non mi ci addentro).
Certamente uno degli innegabili vantaggi delle micro-economie nelle micro-comunità è la "tracciabilità protezionistica" che alimenta la suddetta "fede": se dono un giubbotto, quando poi lo vedo indossato da qualcuno della comunità, lo riconosco e riconosco che il dono non è stato vano (certo, se lo vedo indosso al ricco latifondista del paese, inizio a sospettare della "professionalità" del "sacerdote"). Su alcuni cassonetti di raccolta, almeno dalle mie parti, girano voci spiacevoli, che inevitabilmente mortificano la "fede" del donatore che, nella macro-economia della macro-comunità, già sa che probabilmente non vedrà il suo giubbotto addosso a qualcuno, perché l'"amministratore del tempio" dispone di una rete di distribuzione che va oltre le frequentazioni del donatore. Il dono come sacrificio avulso da un riscontro, secondo me, richiede o molta "fede" o molto surplus, entrambi peculiarità non eccessivamente tipiche della popolazione media.
Forse è proprio questo il nodo centrale: la gran parte dei potenziali donatori, quanto più sa che non troverà riscontro tangibile del suo dono e quanto più sa che il suo dono si disperderà fra mille doni che rallegreranno sconosciuti (estranei alla sua comunità), tanto più ha bisogno dell'incentivo motivazionale di un feedback (magari non necessariamente della gamification, comunque non totalmente ingenua, proposta dal prete con la "top 10" dei donatori, in stile classifica "high scores" del flipper/pinball in sala giochi; non a caso, mi sembra anche l'Avis proponga un'incentivante classifica del genere in base al sangue donato, se non ricordo male). Intendo che, secondo me, si è maggiormente inclini a donare in anonimato per la propria comunità il proprio surplus, tanto più se si è consapevoli del valore relativo-contestuale di ciò che si dona (e si ha pubblico riscontro, non del "merito medagliato" ma dell'effetto del dono), piuttosto che donare al mondo intero una goccia del mare senza ricevere nemmeno un bigliettino di ringraziamento (intendiamoci, c'è chi lo fa, ma in generale non mi sembra una forma economica proponibile sistematicamente). In fondo è lo stesso "movente dell'appartenenza" per cui magari raccogliamo una cartaccia per le strade della nostra comunità, ma quando siamo turisti, non dico siamo i primi a gettarla, ma magari tendiamo a pensare che raccoglierla non ci riguardi più di tanto. Aver cura del mondo come della propria micro-comunità sarebbe uno slogan da "pubblicità progresso" ingenuamente ottimista, che cozza con la constatabile "banalità" della natura umana.
Ben vengano forme di dono e "sacrificio" nelle piccole comunità, ma, proprio come gli equilibri e l'autosostentamento delle comuni, dubito siano scalabili su intere popolazioni (e proprio per questo i "templi" si distinguono come "oasi del sacrificio"); non vorrei dire che la semplicità del dono è sistemicamente costretta a restare sottomessa alle complessità e alle difficoltà delle grandi comunità, ma ormai l'ho già scritto.
C'è poi da considerare che il dono è solitamente figlio del surplus, che in quanto tale presuppone la paternità dell'economia del credito/debito, produzione/commercio, vendita/acquisto (o, ostracizzando il denaro, scambio/resa). Nessuno porta al tempio l'unico maiale che ha (e in una società fatta anche di servizi, oltre che di beni, la metafora si complicherebbe ulteriormente, ma non mi ci addentro).
Certamente uno degli innegabili vantaggi delle micro-economie nelle micro-comunità è la "tracciabilità protezionistica" che alimenta la suddetta "fede": se dono un giubbotto, quando poi lo vedo indossato da qualcuno della comunità, lo riconosco e riconosco che il dono non è stato vano (certo, se lo vedo indosso al ricco latifondista del paese, inizio a sospettare della "professionalità" del "sacerdote"). Su alcuni cassonetti di raccolta, almeno dalle mie parti, girano voci spiacevoli, che inevitabilmente mortificano la "fede" del donatore che, nella macro-economia della macro-comunità, già sa che probabilmente non vedrà il suo giubbotto addosso a qualcuno, perché l'"amministratore del tempio" dispone di una rete di distribuzione che va oltre le frequentazioni del donatore. Il dono come sacrificio avulso da un riscontro, secondo me, richiede o molta "fede" o molto surplus, entrambi peculiarità non eccessivamente tipiche della popolazione media.
Forse è proprio questo il nodo centrale: la gran parte dei potenziali donatori, quanto più sa che non troverà riscontro tangibile del suo dono e quanto più sa che il suo dono si disperderà fra mille doni che rallegreranno sconosciuti (estranei alla sua comunità), tanto più ha bisogno dell'incentivo motivazionale di un feedback (magari non necessariamente della gamification, comunque non totalmente ingenua, proposta dal prete con la "top 10" dei donatori, in stile classifica "high scores" del flipper/pinball in sala giochi; non a caso, mi sembra anche l'Avis proponga un'incentivante classifica del genere in base al sangue donato, se non ricordo male). Intendo che, secondo me, si è maggiormente inclini a donare in anonimato per la propria comunità il proprio surplus, tanto più se si è consapevoli del valore relativo-contestuale di ciò che si dona (e si ha pubblico riscontro, non del "merito medagliato" ma dell'effetto del dono), piuttosto che donare al mondo intero una goccia del mare senza ricevere nemmeno un bigliettino di ringraziamento (intendiamoci, c'è chi lo fa, ma in generale non mi sembra una forma economica proponibile sistematicamente). In fondo è lo stesso "movente dell'appartenenza" per cui magari raccogliamo una cartaccia per le strade della nostra comunità, ma quando siamo turisti, non dico siamo i primi a gettarla, ma magari tendiamo a pensare che raccoglierla non ci riguardi più di tanto. Aver cura del mondo come della propria micro-comunità sarebbe uno slogan da "pubblicità progresso" ingenuamente ottimista, che cozza con la constatabile "banalità" della natura umana.
Ben vengano forme di dono e "sacrificio" nelle piccole comunità, ma, proprio come gli equilibri e l'autosostentamento delle comuni, dubito siano scalabili su intere popolazioni (e proprio per questo i "templi" si distinguono come "oasi del sacrificio"); non vorrei dire che la semplicità del dono è sistemicamente costretta a restare sottomessa alle complessità e alle difficoltà delle grandi comunità, ma ormai l'ho già scritto.