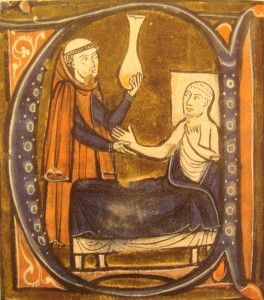La riforma luterana iniziò nell'ottobre del 1517 e Patinir dipinse "La fuga in Egitto" in quel periodo. Fu influenzato dalla nuova dottrina ?
Da tener presente che Patinir conosceva le opere di Hieronymus Bosch, dal quale riprese la capacità di evocare scenari fantastici.
La tendenza al paesaggio come 'tema autonomo' e non sfondo di una scena con figure fu facilitata dalla soluzione dei problemi della prospettiva. Come non pensare a Brunelleschi, Masaccio, a Piero della Francesca e al suo trattato titolato "De prospectiva pingendi".

Nella pittura rinascimentale fu importante l'uso di colori più luminosi.
Leon Battista Alberti, nel suo trattato "De Pictura" del 1435-36, evidenziò come il colore non fosse una caratteristica propria del soggetto, ma dipendesse completamente dalla quantità di luce che investe il soggetto stesso.
E mi sovvengono alla mente i vedutisti veneziani del '700 (Canaletto, Bellotto ed altri); per l'arte olandese la pittura di paesaggio significò realismo ma anche la creazione di un mondo immaginario, da cui nacque, nella pittura francese, l'impressionismo: Monet, Manet, Renoir, Sisley, Pissarro. Furono questi a insegnare a guardare in modo nuovo il mondo circostante: per loro, il paesaggio, studiato nei suoi aspetti più labili di luce e di colore, fu una delle massime prove della pittura. Dopo di loro anche il paesaggio si configura secondo le esigenze delle nuove correnti artistiche (Seurat, Cézanne, Van Gogh).
Da tener presente che Patinir conosceva le opere di Hieronymus Bosch, dal quale riprese la capacità di evocare scenari fantastici.
La tendenza al paesaggio come 'tema autonomo' e non sfondo di una scena con figure fu facilitata dalla soluzione dei problemi della prospettiva. Come non pensare a Brunelleschi, Masaccio, a Piero della Francesca e al suo trattato titolato "De prospectiva pingendi".
Nella pittura rinascimentale fu importante l'uso di colori più luminosi.
Leon Battista Alberti, nel suo trattato "De Pictura" del 1435-36, evidenziò come il colore non fosse una caratteristica propria del soggetto, ma dipendesse completamente dalla quantità di luce che investe il soggetto stesso.
E mi sovvengono alla mente i vedutisti veneziani del '700 (Canaletto, Bellotto ed altri); per l'arte olandese la pittura di paesaggio significò realismo ma anche la creazione di un mondo immaginario, da cui nacque, nella pittura francese, l'impressionismo: Monet, Manet, Renoir, Sisley, Pissarro. Furono questi a insegnare a guardare in modo nuovo il mondo circostante: per loro, il paesaggio, studiato nei suoi aspetti più labili di luce e di colore, fu una delle massime prove della pittura. Dopo di loro anche il paesaggio si configura secondo le esigenze delle nuove correnti artistiche (Seurat, Cézanne, Van Gogh).