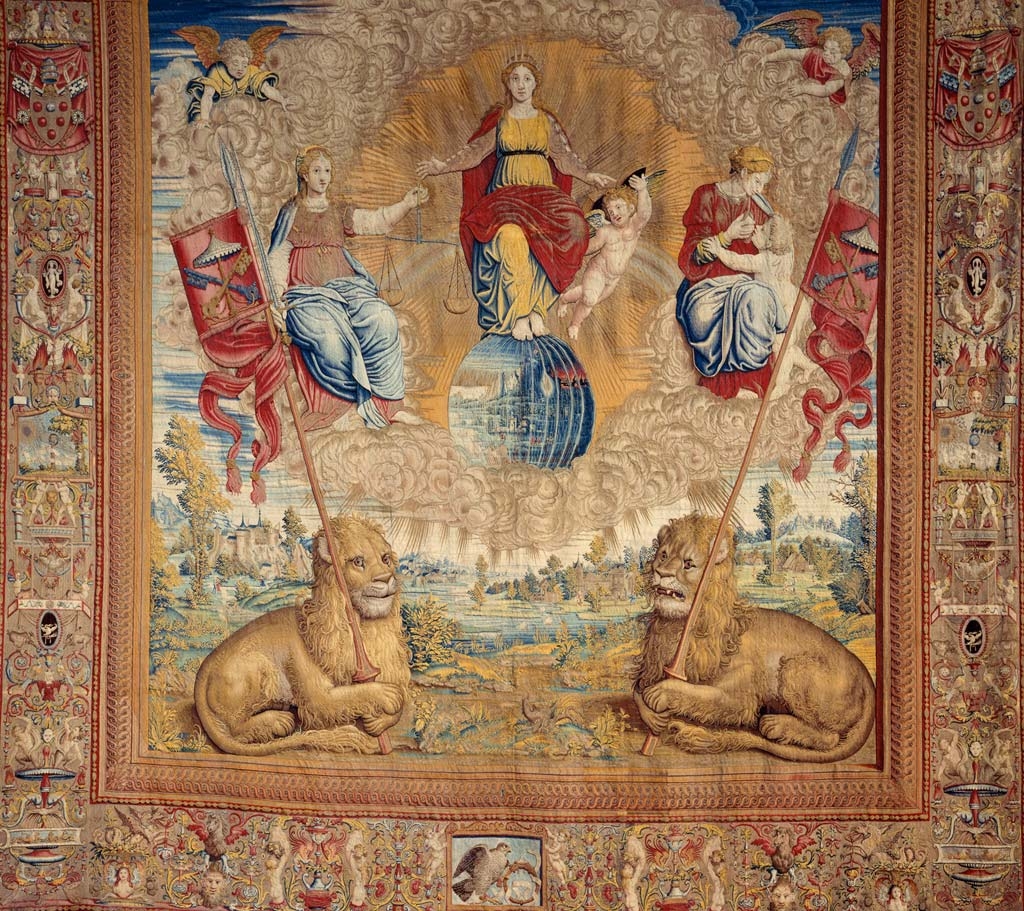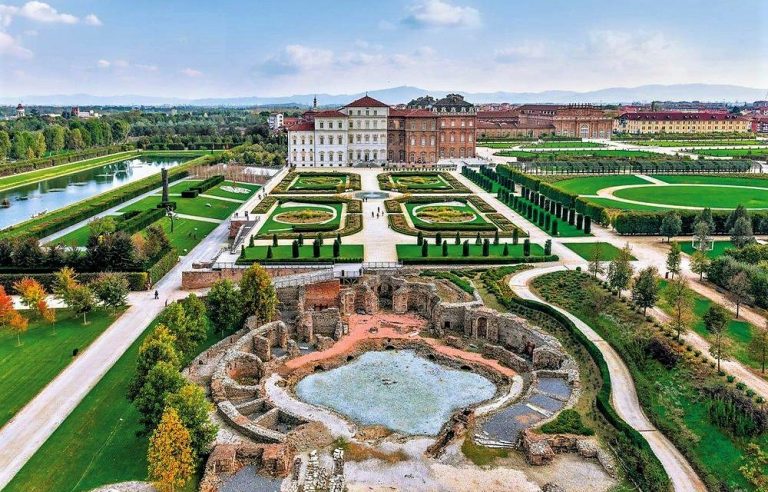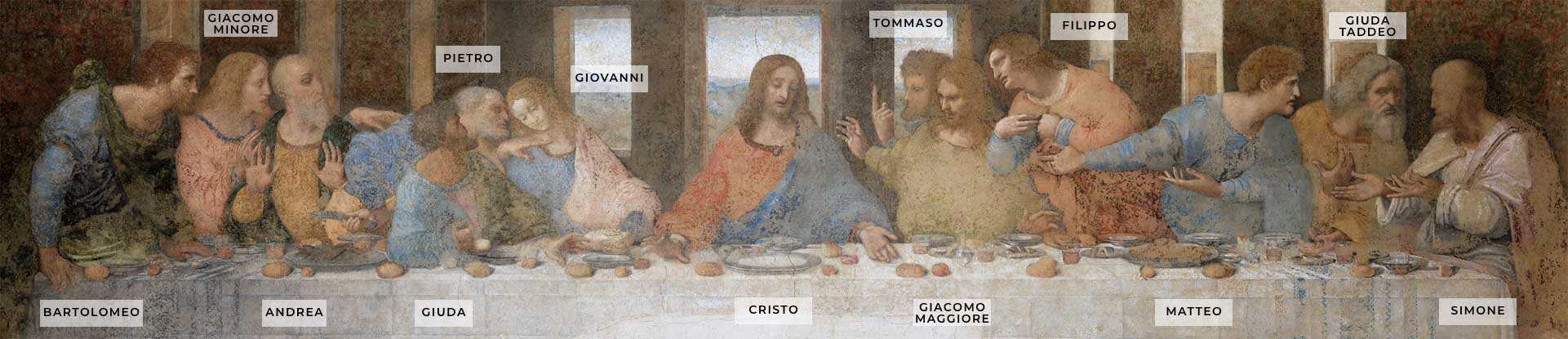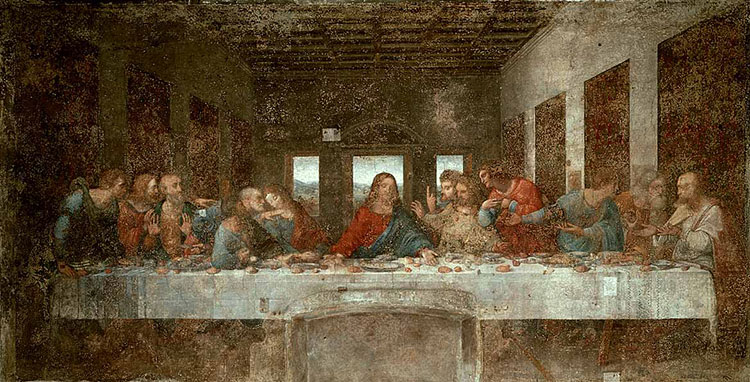Buongiorno Pensar bene.
Hai scritto a Taurus:
Taurus, ed anche io, non crediamo nell'esistenza di Dio, ma culturalmente ci interessa moltissimo la religione. Ci piace constatare le "anomalie" nei cosiddetti "libri sacri" e condividere il nostro pensiero con i credenti, con la speranza di far vacillare le "certezze", specie nei "credenti tiepidi" o negli "atei devoti". Con i "credenti convinti" è inutile il dialogo.
Sono oltre duemila anni che il cristianesimo ci viene propinato dal clero come un tutto dogmatico: questo è, questo devi credere e se contesti sia anatema, sia eresia.
L'Inquisizione, anzi la "Santa Inquisizione" non c'è più. Nel 1908 venne denominata "Sant'Uffizio", successivamente "Congregazione per la dottrina della fede". Anche questa riciclata nell'attuale"Dicasterium pro doctrina fidei".
In Vaticano, o meglio nella "Santa sede" troppe cose vengono definite "sante", ma sante non sono.
La Chiesa cattolica sopravvive perché si adatta ai tempi. Nei hai l'esempio anche con le modifiche alle preghiere.
Sono d'accordo con te riguardo la problematica "salute mentale" di Paolo. Però aveva un'intelligenza superiore alla media e un'ampia cultura, in particolare filosofica e teologica, tale da permettergli di essere il "fondatore" della religione cristiana. Non ci sono prove, ma mi piace pensare che la sua formazione culturale sia avvenuta nell'ambito del rabbinato giudaico.
Lieta giornata
Hai scritto a Taurus:
CitazioneSe te ne freghi della ragione, perchè ragioni su cose di cui non ti importa niente?
Taurus, ed anche io, non crediamo nell'esistenza di Dio, ma culturalmente ci interessa moltissimo la religione. Ci piace constatare le "anomalie" nei cosiddetti "libri sacri" e condividere il nostro pensiero con i credenti, con la speranza di far vacillare le "certezze", specie nei "credenti tiepidi" o negli "atei devoti". Con i "credenti convinti" è inutile il dialogo.
Sono oltre duemila anni che il cristianesimo ci viene propinato dal clero come un tutto dogmatico: questo è, questo devi credere e se contesti sia anatema, sia eresia.

L'Inquisizione, anzi la "Santa Inquisizione" non c'è più. Nel 1908 venne denominata "Sant'Uffizio", successivamente "Congregazione per la dottrina della fede". Anche questa riciclata nell'attuale"Dicasterium pro doctrina fidei".
In Vaticano, o meglio nella "Santa sede" troppe cose vengono definite "sante", ma sante non sono.
La Chiesa cattolica sopravvive perché si adatta ai tempi. Nei hai l'esempio anche con le modifiche alle preghiere.
Sono d'accordo con te riguardo la problematica "salute mentale" di Paolo. Però aveva un'intelligenza superiore alla media e un'ampia cultura, in particolare filosofica e teologica, tale da permettergli di essere il "fondatore" della religione cristiana. Non ci sono prove, ma mi piace pensare che la sua formazione culturale sia avvenuta nell'ambito del rabbinato giudaico.
Lieta giornata


 .
.