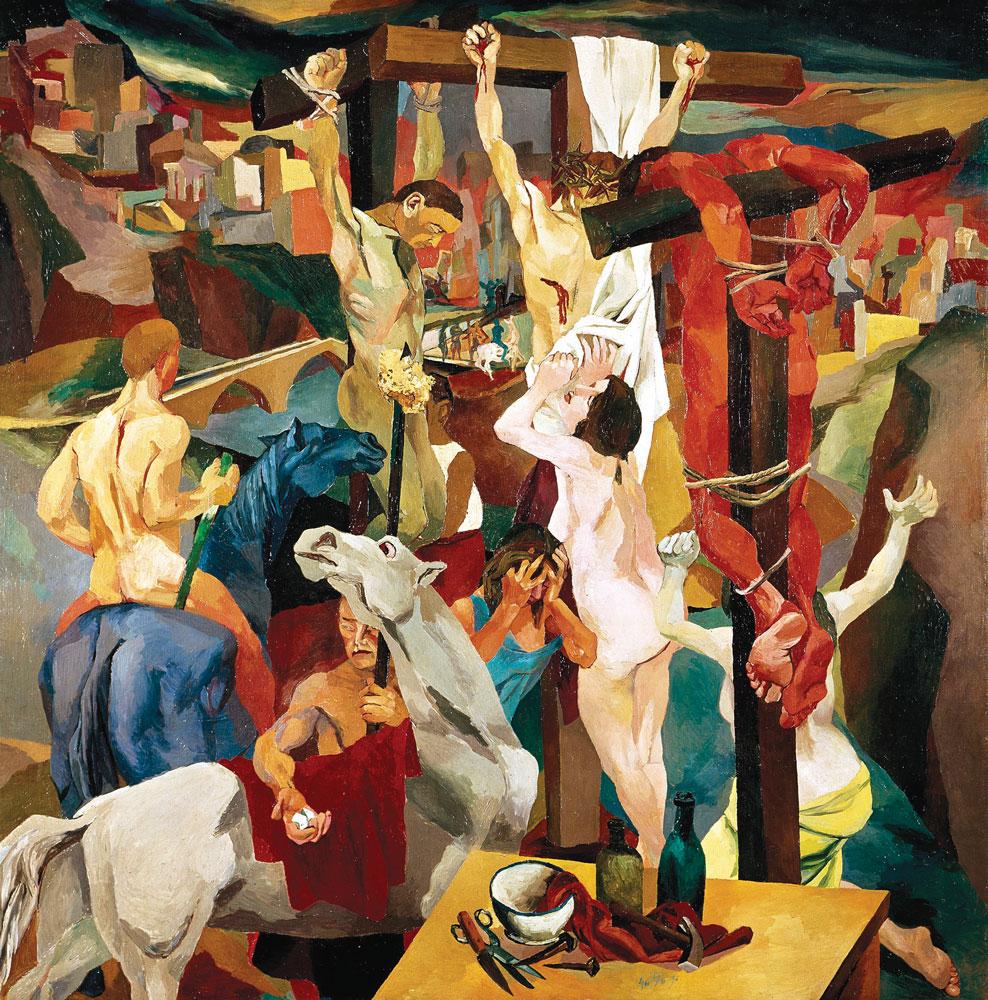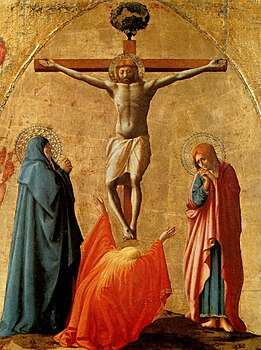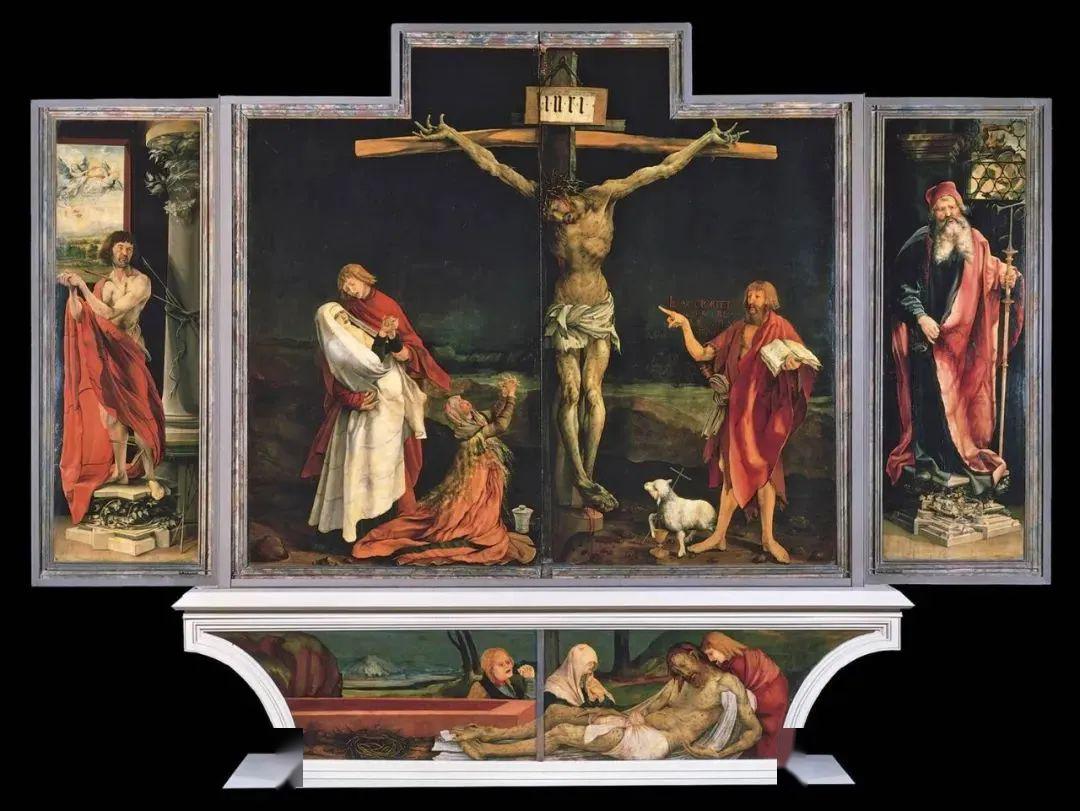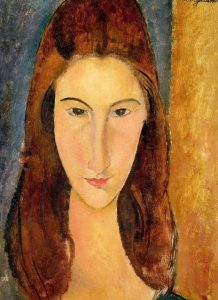Dal 15 marzo è in vendita il libro titolato "Il sorriso di Caterina. La madre di Leonardo" (pagg. 528, euro 19), scritto da Carlo Vecce, docente di letteratura italiana all'Università di Napoli, studioso di Leonardo da Vinci.
Il prof. Vecce ha rinvenuto nell'Archivio di Stato di Firenze un documento notarile del 2 novembre 1452 che in parte modifica la biografia di Leonardo da Vinci, che nacque ad Anchiano (frazione del Comune di Vinci) il 15 aprile 1452 e morì ad Amboise (un Comune francese) nel 1519.
L'atto notarile fu rogato da Piero da Vinci, padre di Leonardo, su istanza di Ginevra d'Antonio Redditi, moglie di Donato di Filippo di Silvestro Nati, proprietaria della schiava di nome Caterina "filia Jacobi eius schiava seu serva de partibus Cirassie".
Questa Caterina era la ragazza che poi divenne la madre di Leonardo.
Il documento attesta la liberazione dal vincolo schiavile della giovane da parte della sua padrona, donna Ginevra.
Quindi la madre di Leonardo, diversamente da quanto creduto fino a poco tempo fa, non era un'umile ragazza della campagna toscana, ma originaria della Circassia, regione del Caucaso e giunta a Firenze come schiava.
L'autore del libro ha idealmente ricostruito il viaggio di Caterina dalle montagne del Caucaso fino al Mare d'Azov, alla foce del fiume Don. Qui venne fatta imbarcare e dopo aver attraversato il Mar Nero, nel 1439 arrivò a Costantinopoli dove fu comprata da mercanti veneziani.
Giunta a Venezia, nel 1442, quando aveva circa 15 anni, venne acquistata come schiava dal suddetto commerciante Donato Nati, che a Firenze abitava a ridosso della chiesa di San Michele Visdomini.
Il Nati poi dette la ragazza "in affitto" al notaio Piero da Vinci, perché le serviva come balia a Maria, la sua prima figlia.
Caterina riceveva 18 fiorini all'anno, un costo elevato in quell'epoca per la mansione servile, ma secondo il prof. Vecce bisogna tener presente che la ragazza veniva anche "usata" sessualmente dal notaio, che aveva l'abitazione a Firenze nel Palazzo Castellani, oggi sede del Museo Galileo Galilei.
Leonardo fu il primogenito del notaio Piero ma non di Caterina, perché in precedenza la ragazza aveva avuto un figlio da un altro, secondo quanto scritto nelle "Ricordanze" dal letterato umanista Francesco di Matteo Castellani.
In seguito Caterina sposò Antonio Butti, detto "attaccabrighe", e visse vicino a Vinci, dando alla luce altri cinque figli: quattro femmine e un maschio. In totale ebbe 6 figli, compreso Leonardo.
Quando le morì il marito, la donna si trasferì a Milano e visse con il figlio, scienziato ed artista, in quegli anni al servizio di Ludovico il Moro.
In uno scritto del 16 luglio 1493 Leonardo dice che la madre è con lui.
L'anno dopo annota che è morta tra le sue braccia e che per il funerale spese 120 soldi.
Fu sepolta a Milano, forse nella chiesa di San Francesco Grande, che custodiva le reliquie di alcuni santi e vi furono sepolti numerosi appartenenti di famiglie nobili milanesi, come i Borromeo, i Moriggia e i Corio.
In quel tempo Leonardo era impegnato in questa chiesa per dipingere nella Cappella dell'Immacolata Concezione la seconda versione della "Vergine delle rocce", commissionata dalla locale Confraternita dell'Immacolata Concezione di Maria.
Nel 1806 sia la chiesa sia l'annesso convento francescano furono demoliti per consentire la costruzione di una caserma, che attualmente sta subendo la ristrutturazione perché in parte serve come ampliamento dell'Università Cattolica.
Durante gli scavi al di sotto della caserma sono tornati alla luce i resti della chiesa di San Francesco Grande, vari luoghi di sepoltura e le volte di alcune cappelle, fra le quali quella dedicata all'Immacolata Concezione. Di questa sono emersi il muro al quale era addossato l'altare, il pavimento, la cripta (con confusi resti umani di antiche sepolture, forse anche di Caterina), i frammenti di cielo stellato dipinto sulla volta dagli Zavattari: una famiglia di pittori, attivi in Lombardia nel XV secolo. Avevano a Milano la loro bottega d'arte.
segue
Il prof. Vecce ha rinvenuto nell'Archivio di Stato di Firenze un documento notarile del 2 novembre 1452 che in parte modifica la biografia di Leonardo da Vinci, che nacque ad Anchiano (frazione del Comune di Vinci) il 15 aprile 1452 e morì ad Amboise (un Comune francese) nel 1519.
L'atto notarile fu rogato da Piero da Vinci, padre di Leonardo, su istanza di Ginevra d'Antonio Redditi, moglie di Donato di Filippo di Silvestro Nati, proprietaria della schiava di nome Caterina "filia Jacobi eius schiava seu serva de partibus Cirassie".
Questa Caterina era la ragazza che poi divenne la madre di Leonardo.
Il documento attesta la liberazione dal vincolo schiavile della giovane da parte della sua padrona, donna Ginevra.
Quindi la madre di Leonardo, diversamente da quanto creduto fino a poco tempo fa, non era un'umile ragazza della campagna toscana, ma originaria della Circassia, regione del Caucaso e giunta a Firenze come schiava.
L'autore del libro ha idealmente ricostruito il viaggio di Caterina dalle montagne del Caucaso fino al Mare d'Azov, alla foce del fiume Don. Qui venne fatta imbarcare e dopo aver attraversato il Mar Nero, nel 1439 arrivò a Costantinopoli dove fu comprata da mercanti veneziani.
Giunta a Venezia, nel 1442, quando aveva circa 15 anni, venne acquistata come schiava dal suddetto commerciante Donato Nati, che a Firenze abitava a ridosso della chiesa di San Michele Visdomini.
Il Nati poi dette la ragazza "in affitto" al notaio Piero da Vinci, perché le serviva come balia a Maria, la sua prima figlia.
Caterina riceveva 18 fiorini all'anno, un costo elevato in quell'epoca per la mansione servile, ma secondo il prof. Vecce bisogna tener presente che la ragazza veniva anche "usata" sessualmente dal notaio, che aveva l'abitazione a Firenze nel Palazzo Castellani, oggi sede del Museo Galileo Galilei.
Leonardo fu il primogenito del notaio Piero ma non di Caterina, perché in precedenza la ragazza aveva avuto un figlio da un altro, secondo quanto scritto nelle "Ricordanze" dal letterato umanista Francesco di Matteo Castellani.
In seguito Caterina sposò Antonio Butti, detto "attaccabrighe", e visse vicino a Vinci, dando alla luce altri cinque figli: quattro femmine e un maschio. In totale ebbe 6 figli, compreso Leonardo.
Quando le morì il marito, la donna si trasferì a Milano e visse con il figlio, scienziato ed artista, in quegli anni al servizio di Ludovico il Moro.
In uno scritto del 16 luglio 1493 Leonardo dice che la madre è con lui.
L'anno dopo annota che è morta tra le sue braccia e che per il funerale spese 120 soldi.
Fu sepolta a Milano, forse nella chiesa di San Francesco Grande, che custodiva le reliquie di alcuni santi e vi furono sepolti numerosi appartenenti di famiglie nobili milanesi, come i Borromeo, i Moriggia e i Corio.
In quel tempo Leonardo era impegnato in questa chiesa per dipingere nella Cappella dell'Immacolata Concezione la seconda versione della "Vergine delle rocce", commissionata dalla locale Confraternita dell'Immacolata Concezione di Maria.
Nel 1806 sia la chiesa sia l'annesso convento francescano furono demoliti per consentire la costruzione di una caserma, che attualmente sta subendo la ristrutturazione perché in parte serve come ampliamento dell'Università Cattolica.
Durante gli scavi al di sotto della caserma sono tornati alla luce i resti della chiesa di San Francesco Grande, vari luoghi di sepoltura e le volte di alcune cappelle, fra le quali quella dedicata all'Immacolata Concezione. Di questa sono emersi il muro al quale era addossato l'altare, il pavimento, la cripta (con confusi resti umani di antiche sepolture, forse anche di Caterina), i frammenti di cielo stellato dipinto sulla volta dagli Zavattari: una famiglia di pittori, attivi in Lombardia nel XV secolo. Avevano a Milano la loro bottega d'arte.
segue