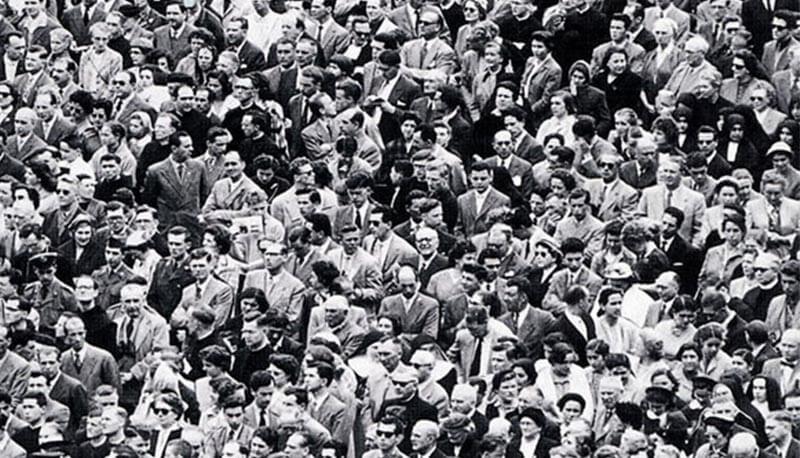A proposito dei provinciali e della vita in provincia, vi faccio leggere un estratto dell'articolo di Franco Arminio, scrittore e regista, pubblicato la scorsa domenica sull'inserto "Robinson" de "la Repubblica".
"Quando vado in giro non chiedo più: 'Che c'è in questo paese ?' La risposta è sempre stata la stessa: 'Qua non c'è niente'. La risposta tipica dello scoraggiatore militante, del fallito che si adopera con successo a far fallire la vita degli altri. Queste persone esercitano una vera e propria egemonia culturale nei luoghi in cui vivono. E purtroppo in questi anni hanno visto confermate le loro teorie ogni volta che chiudeva una scuola o un negozio, ogni volta che un ragazzo partiva.
Ora ho una mappa chiara dei regni degli scoraggiatori, potrei scrivere una guida ai cantieri della sfiducia. La Calabria è sicuramente l'aula magna delle occasioni mancate, del rimpianto su quello che poteva essere e non è stato. Poteva nascere solo qui, a Soveria Mannelli, il 'Festival del lamento ', solo qui poteva essere esplicitata la vocazione più profonda di un territorio. E' sempre buon segno quando si fa amicizia coi propri difetti, quando si capisce che non bisogna rimuoverli e neppure esaltarli, semplicemente accogliere che abbiamo tante voci e devono dialogare per concorrere al governo di una persona o di un luogo. Lamentarsi va bene se sappiamo lamentarci o ironizzare sui nostri lamenti. E se sappiamo farlo assieme".
[...]
"Il Festival del lamento è una buona occasione per capire che portare il broncio ai propri luoghi è un errore grave quanto quello di considerarli un paradiso: se così fosse sarebbe davvero inspiegabile perché è proprio dai cosiddetti paradisi che si emigra di più".

"Quando vado in giro non chiedo più: 'Che c'è in questo paese ?' La risposta è sempre stata la stessa: 'Qua non c'è niente'. La risposta tipica dello scoraggiatore militante, del fallito che si adopera con successo a far fallire la vita degli altri. Queste persone esercitano una vera e propria egemonia culturale nei luoghi in cui vivono. E purtroppo in questi anni hanno visto confermate le loro teorie ogni volta che chiudeva una scuola o un negozio, ogni volta che un ragazzo partiva.
Ora ho una mappa chiara dei regni degli scoraggiatori, potrei scrivere una guida ai cantieri della sfiducia. La Calabria è sicuramente l'aula magna delle occasioni mancate, del rimpianto su quello che poteva essere e non è stato. Poteva nascere solo qui, a Soveria Mannelli, il 'Festival del lamento ', solo qui poteva essere esplicitata la vocazione più profonda di un territorio. E' sempre buon segno quando si fa amicizia coi propri difetti, quando si capisce che non bisogna rimuoverli e neppure esaltarli, semplicemente accogliere che abbiamo tante voci e devono dialogare per concorrere al governo di una persona o di un luogo. Lamentarsi va bene se sappiamo lamentarci o ironizzare sui nostri lamenti. E se sappiamo farlo assieme".
[...]
"Il Festival del lamento è una buona occasione per capire che portare il broncio ai propri luoghi è un errore grave quanto quello di considerarli un paradiso: se così fosse sarebbe davvero inspiegabile perché è proprio dai cosiddetti paradisi che si emigra di più".