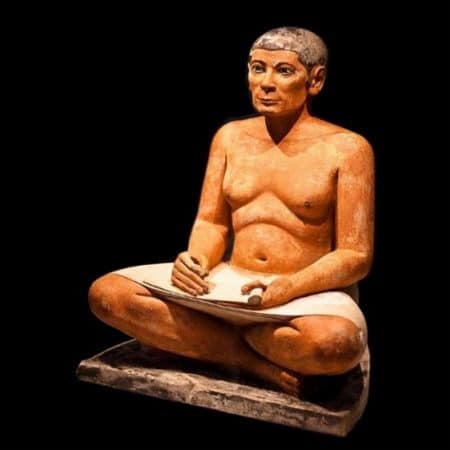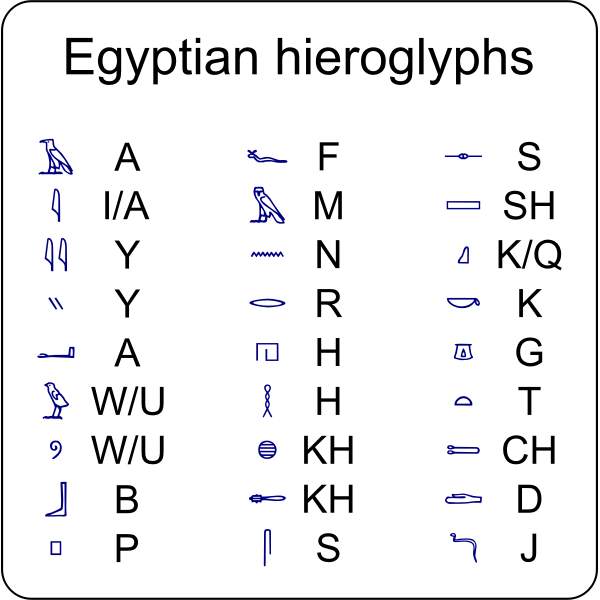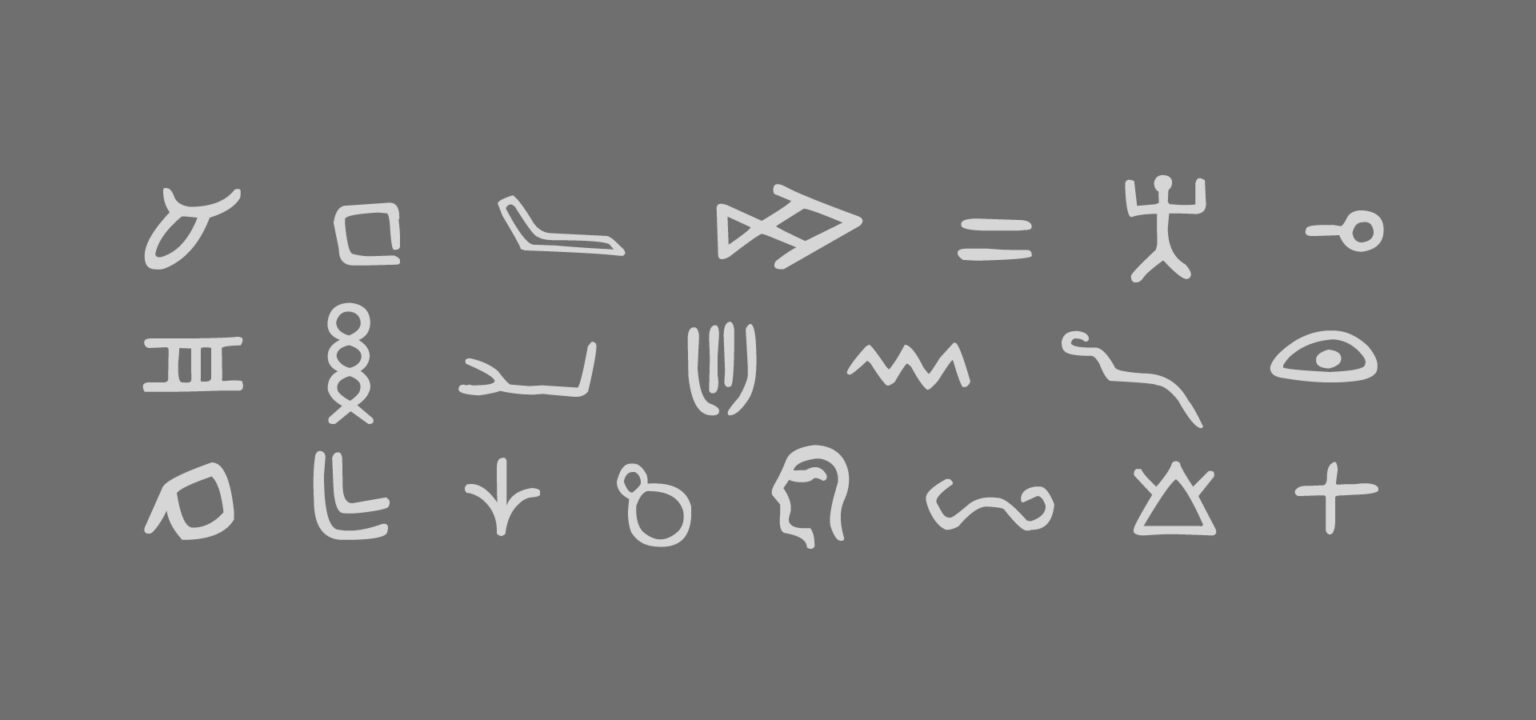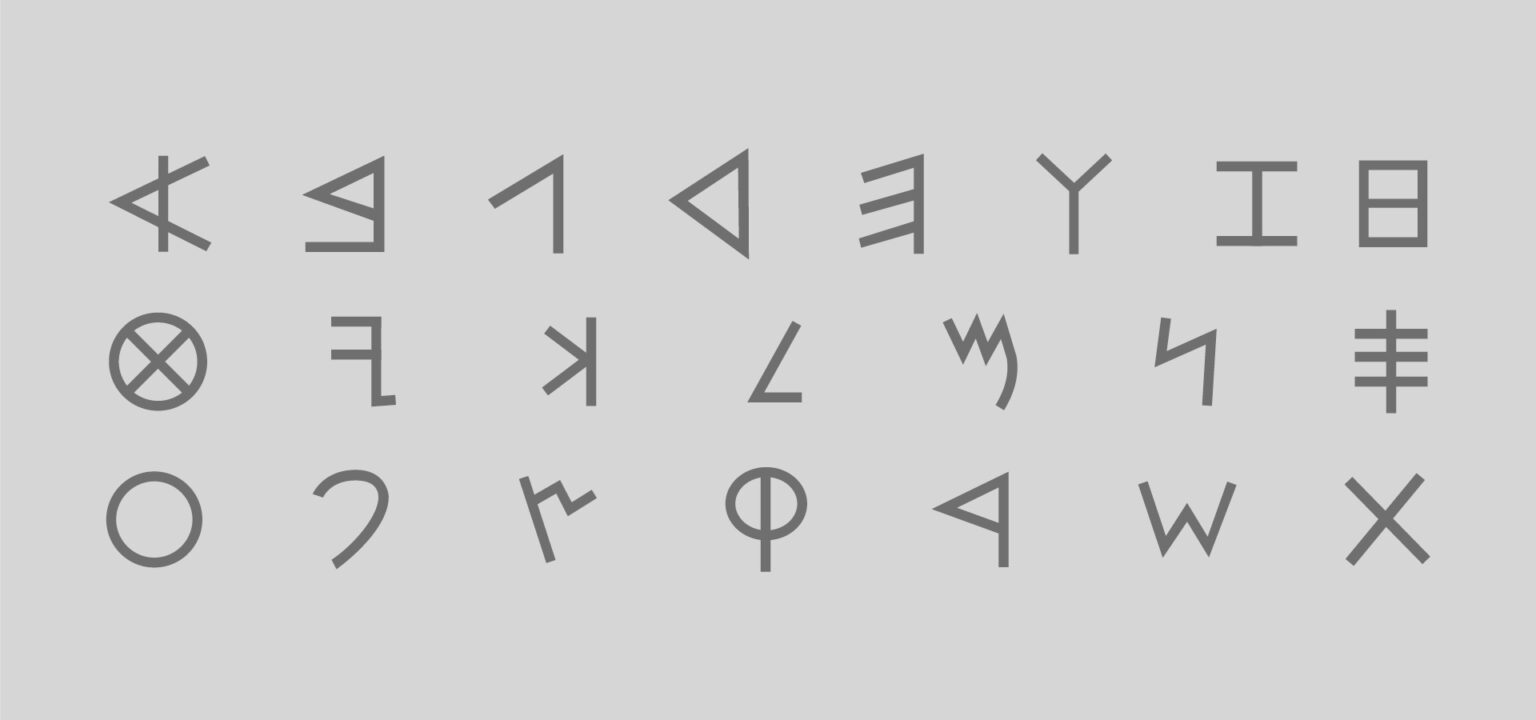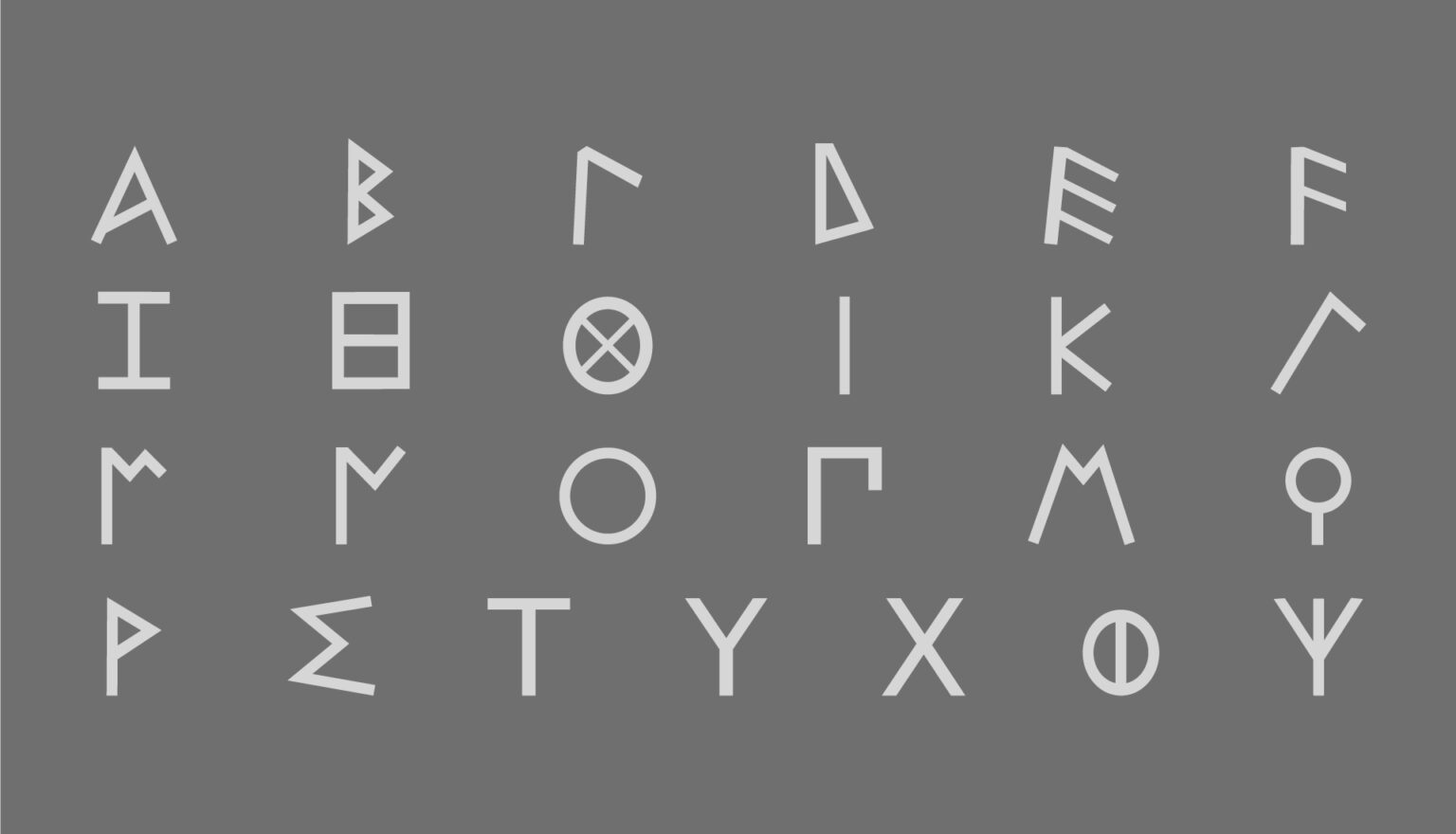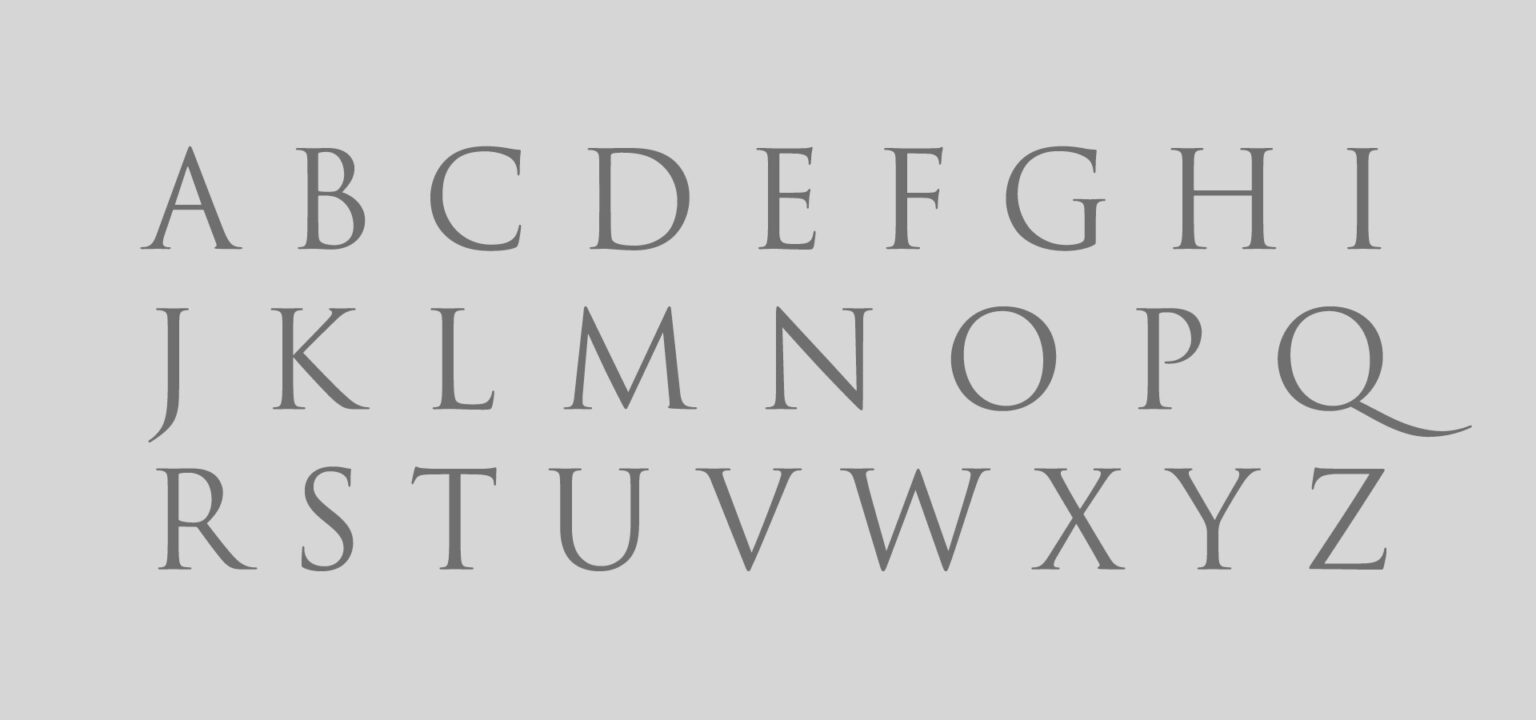I due citati autori del libro evidenziano che "ll presepe francescano rappresenta la Natività, il presepe napoletano l'umanità; e per questo ha conquistato l'immaginario globale, ed è amato da credenti e non credenti".
Per Niola e Moro la versione partenopea della nascita di Gesù è un teatro della devozione: si fondono e si confondono sacro e profano. In poco spazio ci sono le statuine che raffigurano la "folla multicolore e multietnica: pastori, mercanti, suonatori, venditori ambulanti, osti, lavandaie, cuoche contadine, tessitrici, balie, re neri, visir ottomani, schiavi nubiani. Cui anno dopo anno si aggiungono personaggi dell'attualità".
In merito ai personaggi dell'attualità vi faccio leggere un po' di righe scritte dai due docenti.
"Fu Antonio Bassolino, sindaco della città (Napoli), il primo fra i politici a troneggiare sui banchi di via San Gregorio Ameno, il cuore antico dell'arte presepiale napoletana. Sigaretta fra le dita, mani aperte nel gesto di arringare la folla, addirittura aureolato, con il capo circondato da stelline luminose come quello dei santi. Da allora il presepe è diventato un andirivieni di personaggi contemporanei spinti e risucchiati dall'onda della cronaca, una sorta di borsino della popolarità in continua oscillazione.
Dopo Bassolino fu il turno dei 'pastori dalle mani pulite' a far risuonare tra la grotta e la taverna l'eco di Tangentopoli. Fu allora che il pool milanese, con in testa Antonio Di Pietro, fece il suo ingresso in scena, accanto alle figure di sempre, come Benino il dormiente e i Re Magi, la Sacra Famiglia e il pastore della meraviglia.
Con fulmineo tempismo nel 1994 comparve un'attonita statuetta di Berlusconi con in mano un foglio recante l'avviso di garanzia, esposto insieme a Umberto Bossi in canottiera che inalberava un cartello esaltante la virilità leghista in termini crudamente anatomici. Era solo il primo atto di quel teatrino della politica che da allora non ha più abbandonato il presepe. [...]
Ai politici fecero seguito i personaggi dello spettacolo, dello sport e perfino del gossip. E il presepe uscì dai suoi confini per farsi sempre più glocal.
Qualcuno gridò al sacrilegio vedendo in questa contaminazione la fine del presepe. Ma in realtà questo turn over iconografico, che associa i tempi lunghi di una tradizione immemoriale e quelli corti di una storia in cui risuona l'eco immediata della cronaca, hanno sempre caratterizzato il presepe napoletano, facendone una teatrale miniatura del tempo. O meglio dei tempi, sottratti al fluire lineare degli eventi e acronicamente coesistenti".
Inoltre: "A Napoli la nascita di Gesù Bambino ha come sfondo il Vesuvio, le montagne appenniniche e le rovine di Pompei. Insomma il presepe è un plastico del dogma teologico della Natività. Ma è anche arte, tradizione, colore locale. Ethos e phatos, sentimento e passione, rito e teatro. Di fatto, il Vangelo in dialetto".
Il sovrappopolamento urbano si trasferisce sulla cartapesta e diventa folla animata e concitata. E' la vita quotidiana sorpresa in un fermo immagine che la consegna all'eternità.
Per Niola e Moro la versione partenopea della nascita di Gesù è un teatro della devozione: si fondono e si confondono sacro e profano. In poco spazio ci sono le statuine che raffigurano la "folla multicolore e multietnica: pastori, mercanti, suonatori, venditori ambulanti, osti, lavandaie, cuoche contadine, tessitrici, balie, re neri, visir ottomani, schiavi nubiani. Cui anno dopo anno si aggiungono personaggi dell'attualità".
In merito ai personaggi dell'attualità vi faccio leggere un po' di righe scritte dai due docenti.
"Fu Antonio Bassolino, sindaco della città (Napoli), il primo fra i politici a troneggiare sui banchi di via San Gregorio Ameno, il cuore antico dell'arte presepiale napoletana. Sigaretta fra le dita, mani aperte nel gesto di arringare la folla, addirittura aureolato, con il capo circondato da stelline luminose come quello dei santi. Da allora il presepe è diventato un andirivieni di personaggi contemporanei spinti e risucchiati dall'onda della cronaca, una sorta di borsino della popolarità in continua oscillazione.
Dopo Bassolino fu il turno dei 'pastori dalle mani pulite' a far risuonare tra la grotta e la taverna l'eco di Tangentopoli. Fu allora che il pool milanese, con in testa Antonio Di Pietro, fece il suo ingresso in scena, accanto alle figure di sempre, come Benino il dormiente e i Re Magi, la Sacra Famiglia e il pastore della meraviglia.
Con fulmineo tempismo nel 1994 comparve un'attonita statuetta di Berlusconi con in mano un foglio recante l'avviso di garanzia, esposto insieme a Umberto Bossi in canottiera che inalberava un cartello esaltante la virilità leghista in termini crudamente anatomici. Era solo il primo atto di quel teatrino della politica che da allora non ha più abbandonato il presepe. [...]
Ai politici fecero seguito i personaggi dello spettacolo, dello sport e perfino del gossip. E il presepe uscì dai suoi confini per farsi sempre più glocal.
Qualcuno gridò al sacrilegio vedendo in questa contaminazione la fine del presepe. Ma in realtà questo turn over iconografico, che associa i tempi lunghi di una tradizione immemoriale e quelli corti di una storia in cui risuona l'eco immediata della cronaca, hanno sempre caratterizzato il presepe napoletano, facendone una teatrale miniatura del tempo. O meglio dei tempi, sottratti al fluire lineare degli eventi e acronicamente coesistenti".
Inoltre: "A Napoli la nascita di Gesù Bambino ha come sfondo il Vesuvio, le montagne appenniniche e le rovine di Pompei. Insomma il presepe è un plastico del dogma teologico della Natività. Ma è anche arte, tradizione, colore locale. Ethos e phatos, sentimento e passione, rito e teatro. Di fatto, il Vangelo in dialetto".
Il sovrappopolamento urbano si trasferisce sulla cartapesta e diventa folla animata e concitata. E' la vita quotidiana sorpresa in un fermo immagine che la consegna all'eternità.