Non c'è affatto da scusarsi, anzi mi hai fatto ripassare un po' di matematica che male non fa. Per quanto riguarda la calcolatrice, ho usato quella di Windows (calc.exe o link "annidato" nel menu avvio), offline e sempre affidabile.
- Benvenuto su LOGOS.
Questa sezione ti permette di visualizzare tutti i messaggi inviati da questo utente. Nota: puoi vedere solo i messaggi inviati nelle aree dove hai l'accesso.
#662
Tematiche Filosofiche / Re: Il teorema di Eutidemo :-D
28 Febbraio 2023, 14:46:19 PM
Forse non ho capito il senso del dialogo, ma mi sembra solo una questione di arrotondamento: il lato del terreno (se perfettamente quadrato) è esattamente 70,880180586677401607964500390145 metri, che elevato al quadrato dà senza arrotondare i 5024 metri quadri di partenza. Per dividerlo per quattro occorrono quattro quadrati da 35,440090293338700803982250195073 metri per lato (esattamente 1256 metri quadrati per ogni sotto-quadrato).
Nella realtà si procederà ovviamente per approssimazione grossolana, non certo al millimetro, nel dividere la proprietà, ma matematicamente mi sembra filare tutto liscio (soprattutto se consideriamo che π non è esattamente 3,14 bensì 3,1415926535897932 e oltre, quindi l'area del cerchio non quadra essendo 1.256,63706143591... metri quadri).
Nella realtà si procederà ovviamente per approssimazione grossolana, non certo al millimetro, nel dividere la proprietà, ma matematicamente mi sembra filare tutto liscio (soprattutto se consideriamo che π non è esattamente 3,14 bensì 3,1415926535897932 e oltre, quindi l'area del cerchio non quadra essendo 1.256,63706143591... metri quadri).
#663
Scienza e Tecnologia / Re: Bob e Alice che stanno dicendo?
26 Febbraio 2023, 22:02:23 PM
Già saprai che esiste anche DAN, il "gemello senza filtri" di ChatGPT; se così non fosse, ecco come risvegliarlo (se ancora non l'hanno imbavagliato): https://chatgbt.net/2022/12/17/how-to-get-around-chatgpt-restrictions/
#664
Attualità / Re: Guerra in Ucraina III
26 Febbraio 2023, 21:24:39 PMCitazione di: Ipazia il 26 Febbraio 2023, 19:41:50 PMIl sequitur l'ha spiegato nikoVeramente non mi sembra niko abbia spiegato il (non) sequitur fra la mia osservazione sulla neutralità e il tuo "chiedermi" «Quindi geniale la linea politica "Bandera" del 2014 ? E il "guai ai vinti" russi-ucraini ?»(cit.) e altre "partite giocate" di cui onestamente non so nulla, non seguendo "lo sport" (ciò nonostante credo ancora che fra il canto di una "sirena occidentalizzante" e una "difensiva" mitragliata di AK-47, ci sia una netta differenza, etica e non solo, in Ucraina come nel resto del mondo).
A proposito di chiarimenti, chiederei, parlando seriamente, spiegazioni su:
Citazione di: niko il 26 Febbraio 2023, 18:13:04 PMIl rispetto del consenso, appunto, interno della sua stessa popolazione, sarebbe stato il sottile filo divisorio tra quello che alcuni di voi chiamano neutralità, e lo definiscono impossibile nel caso dell'Ucraina, e quello che io chiamo equidistanza, e lo definisco assolutamente possibileNon essendo pratico di questi discorsi non colgo la differenza: se il consenso fosse (stato) tendenzialmente in una "direzione", oriente o occidente che sia, come ci sarebbe (stata) di fatto equidistanza?
L'unico consenso che porterebbe all'equidistanza non sarebbe forse un consenso verso la neutralità (semmai percorribile, viste appunto la storia e la posizione)? Oppure intendi che ci sia, guerra a parte, un consenso così "bipolare" (intorno al 50%) da impedire un netto sbilanciamento politico da uno dei due "lati"? Ciò sarebbe , più che equidistanza, una netta (instabile?) tensione interna fra chi vuole andare di qua e chi vuole tornare di là.
Per «equidistanza» intendi rapporti distaccati con entrambi "i cani", da parte di un "osso" (tipo "rubabandiera")?
P.s.
@Jacopus
Credo ora capisca perché altrove mi sono affrettato a sottolineare, fra il serio e il faceto, che Amadeus non è il nuovo Goebbels.
#665
Attualità / Re: Guerra in Ucraina III
26 Febbraio 2023, 17:44:10 PM
@Ipazia
Ribadisco che la geopolitica non è il mio sport, quindi non tifo, pur sapendo che parlando con degli ultras di una squadra è difficile passare per super-partes, se il loro motto è solitamente «o con noi o contro di noi» (come quando i credenti mischiano atei e satanisti perché entrambi non sono pro-Dio). Tutto ciò che segue quel tuo «quindi» è dunque per me un ambizioso non sequitur rispetto alla banalità della mia frase citata. Parlare della plausibilità della neutralità dell'Ucraina significa per me semplicemente guardare la cartina e considerare che l'Ucraina è ex-Urss; InVerno (soprattutto nel primo paragrafo del post 102) ha aggiunto considerazioni più dettagliate ed esplicite che ho trovato ragionevoli, ma se ci accomuni con un generico «voi» gli fai sicuramente un torto, perché è decisamente più competente ed interessato di me sulla faccenda (puoi metterci assieme in quanto entrambi, scommetto, non abbiamo in camera il poster di Putin, ma si torna alla suddetta differenza fra satanisti ad atei; senza voler insinuare che InVerno non sappia la differenza fra Putin e Satana, lo chiarisco prima che niko insorga).
D'altronde, per quanto riguarda la plausibilità della neutralità dell'Ucraina, mi pare che anche tu, se non fraintendo quanto segue, sia piuttosto scettica in merito:
Ribadisco che la geopolitica non è il mio sport, quindi non tifo, pur sapendo che parlando con degli ultras di una squadra è difficile passare per super-partes, se il loro motto è solitamente «o con noi o contro di noi» (come quando i credenti mischiano atei e satanisti perché entrambi non sono pro-Dio). Tutto ciò che segue quel tuo «quindi» è dunque per me un ambizioso non sequitur rispetto alla banalità della mia frase citata. Parlare della plausibilità della neutralità dell'Ucraina significa per me semplicemente guardare la cartina e considerare che l'Ucraina è ex-Urss; InVerno (soprattutto nel primo paragrafo del post 102) ha aggiunto considerazioni più dettagliate ed esplicite che ho trovato ragionevoli, ma se ci accomuni con un generico «voi» gli fai sicuramente un torto, perché è decisamente più competente ed interessato di me sulla faccenda (puoi metterci assieme in quanto entrambi, scommetto, non abbiamo in camera il poster di Putin, ma si torna alla suddetta differenza fra satanisti ad atei; senza voler insinuare che InVerno non sappia la differenza fra Putin e Satana, lo chiarisco prima che niko insorga).
D'altronde, per quanto riguarda la plausibilità della neutralità dell'Ucraina, mi pare che anche tu, se non fraintendo quanto segue, sia piuttosto scettica in merito:
Citazione di: Ipazia il 26 Febbraio 2023, 15:35:53 PMcosa succederà nell'est Europa: o pacificazione senza blocchi militari canaglia a fomentare risse o guerra permanente a più o meno alta intensità.oppure intendi che dopo la pacificazione (e lo chiedo senza retorica) l'Ucraina riuscirà ad essere stabilmente neutrale, avendo neutralizzato le divergenze interne? Potrebbe essere un buon inizio per la (loro) pace (se l'"orso difensivo e pacificatore" permette, ovviamente).
#666
Tematiche Filosofiche / Re: Il paradosso del "raddoppiamento della sfera"
26 Febbraio 2023, 14:54:58 PM
Trovo che la ragionevole istanza di Eutidemo di poter usare il coltello per l'esperimento matematico tocchi il fulcro della questione: la matematica è solo uno strumento per la comprensione astratta del mondo e funziona bene se la applichiamo al mondo, ma se la applichiamo a se stessa può talvolta implodere in paradossi e non-sensi non riscontrabili nella realtà. Prima di voler sperimentare lo sdoppiamento della sfera, basato su astrazioni assiomatiche, basta chiedersi se si può sperimentare l'adimensionalità del punto o la lunghezza infinita di una retta o la bidimensionalità del piano, tutti fondamentali per il funzionamento della geometria (chiaramente non si può, ma concettualmente servono).
Da un segmento è possibile prelevare punti in modo da poter "produrre" un secondo segmento di uguale lunghezza? Concettualmente sì (correggetemi se sbaglio), perché i punti di un segmento sono infiniti, quindi possiamo prelevar punti all'infinito e costruire il segmento-doppione, ma nella realtà il segmento bidimensionale nemmeno esiste (così come il punto o l'infinità di rette che lo attraversano). Si tratta principalmente, secondo me, di saper discernere quando la matematica ci aiuta a parlare del mondo e quando il mondo ci ricorda la convenzionalità della matematica (assiomi, Godel, etc.).
Da un segmento è possibile prelevare punti in modo da poter "produrre" un secondo segmento di uguale lunghezza? Concettualmente sì (correggetemi se sbaglio), perché i punti di un segmento sono infiniti, quindi possiamo prelevar punti all'infinito e costruire il segmento-doppione, ma nella realtà il segmento bidimensionale nemmeno esiste (così come il punto o l'infinità di rette che lo attraversano). Si tratta principalmente, secondo me, di saper discernere quando la matematica ci aiuta a parlare del mondo e quando il mondo ci ricorda la convenzionalità della matematica (assiomi, Godel, etc.).
#667
Attualità / Re: Guerra in Ucraina III
26 Febbraio 2023, 14:40:16 PMCitazione di: niko il 26 Febbraio 2023, 12:47:19 PML'azione dettata dall'etica è sempre quella di ristabilire la pace mediante la costruzione della giustizia.Questo è esattamente ciò che intendevo con micro-etica («micro» non in senso dispregiativo), tanto più ragionevole quanto la macro-etica incappa nell'indecidibilità di uno scacco in cui tutti sembrano aver torto. Concordo circa l'avversione verso i piani inclinati, specialmente quello che porterebbe dall'attitudine di tale micro-etica (dei grossi cani che "esportano la pace") fino alla distopica russificazione dell'Europa, rischio per me tanto plausibile quanto l'islamizzazione dell'Europa paventata da altri discorsi; direi di restare sul piano (in piano) delle problematiche plausibili. A proposito di plausibilità, riguardo la mancata neutralità di uno stato con la storia e la "posizione cuscinetto" dell'Ucraina, credo InVerno abbia già svelato l'arcano.
Detto questo, dico anche che molte guerre, come quella in Ucraina, non hanno nulla a che vedere con il mio concetto di giustizia [...] i due contendenti hanno torto tutti e due, e questo apre, secondo me a un'etica di prospettive realiste per la pace, cioè, che vinca l'unico pesce abbastanza grosso da poter vincere, così almeno pesce grosso e pesce piccolo la smettono di scannarsi.
#668
Tematiche Filosofiche / Re: Il paradosso del "raddoppiamento della sfera"
25 Febbraio 2023, 16:52:56 PM #669
Attualità / Re: Guerra in Ucraina III
25 Febbraio 2023, 15:12:06 PMCitazione di: niko il 25 Febbraio 2023, 10:43:40 AMio sono per la pace, tifo per la Russia solo perche' la Russia da quando ha ridimensionato, realisticamente, appunto, i suoi obbiettivi in Ucraina [...] e' l'unica parte in campo che puo' vincere:Trovo interessante questo conflitto fra realismo ed etica o, latineggiando, fra «si vis pacem para bellum» e «si vis pacem para iustitiam» («se vuoi la pace prepara la guerra» e «se vuoi la pace prepara la giustizia»). Da quel che leggo, da un lato, ci si augura che il gatto non giochi troppo con il topo, se tanto è inevitabile che alla fine se lo mangi; dall'altro, non è scontato, suppongo, che sia etico che il gatto mangi il topo solo perché lui è più grosso (senza voler "degradare" il povero topo ad osso ed "ingrossare" i gatti in cani). Come dire che c'è una micro-etica realista, per cui ci si augura che non ci sia ancora lunga guerra (sofferenza, morti, etc.) e torni presto la pace; affiancata ad una macro-etica che invece riflette su ciò che è giusto a prescindere dalle dimensioni dei contendenti, mettendo invece l'accento sul "fare porcate" e su ciò che è necessario affinché "la giustizia trionfi" (vocabolario non mio, ma qui serve a capirsi). Suppongo che per la macro-etica ogni Davide, se è nel "giusto", faccia bene a combattere contro il Golia di turno, sebbene non sia affatto ovvio che finisca sempre come nella Bibbia; mentre per la micro-etica, c'è da augurarsi che Davide non prolunghi inutilmente il suo sofferente stillicidio per i colpi inferti da Golia e che la cruenta battaglia finisca presto (nel modo prevedibile secondo le stazze in campo), ristabilendo così l'agognata pace.
[...]
Il mio discorso, realistico, e' che prima qualcuno "vince", in questa guerra, e prima si arriva alla pace.
[...]
Se fossimo in Russia, il nemico sarebbe la Russia.
Se vuoi farmi dire che c' e' una differenza ETICA tra porcate n.a.t.o e porcate Russia, no, non lo dico.
Non ho la geopolitica come "sport" preferito, quindi se steste parlando di un (fanta-)conflitto bellico fra Senegal e Gambia (nomi a caso) o fra USA e Cuba (un po' meno a caso), porrei comunque la stessa questione: mi interessa la portata trasversale presente in quanto citato. Se non ho frainteso, mi pare una declinazione ambigua del suddetto «si vis pacem, para bellum»: ossia, nel caso della micro-etica (perché la macro è ben nota come impostazione) "tifare" per il pesce grande affinché mangi al più presto il pesce piccolo così le acque tornino calme e pacificate. Poi, se il pesce grande avrà ancora fame, "tiferemo" ancora affinché inghiotta un altro piccolo senza turbare troppo le acque e così via fino a quando, plausibilmente, saranno rimasti solo pesci grandi e, se avranno fame, le acque allora si muoveranno parecchio. Nel frattempo si saranno estinti i pesci piccoli, che riposeranno in pace, nella (micro?)pace ottenuta grazie alla loro morte.
Non sono certo che Kant (v. qualche pagina addietro) avesse in mente questo quando parlava di pace, né che sia una buona ricetta per la stabilità geopolitica (se la guerra ci è sgradita), quasi convenisse inviare le armi a Putin così che faccia prima a "pacificare" quelle zone.
Chiaramente qui la pace è anche un (primo o secondo, a scelta) fine perché l'obiettivo reale della macro-etica resta comunque la "giustizia": che in questo caso, da quel che mi dite, sarebbe il riportare certi confini ad un determinato periodo storico (scelto secondo certi canoni ideologici), o almeno ad un compromesso che gli assomigli vagamente (e il fatto che se ne parli con passione nella patria di quell'"epifenomeno" dai confini piuttosto mutevoli che fu l'impero romano, per non parlare della penisola ancora in corso di unificazione sociale, non è privo di una certa ironia del destino).
#670
Tematiche Culturali e Sociali / Re: Le morti per armi da fuoco in Italia!
24 Febbraio 2023, 11:22:18 AM
Sono consapevole delle differenze segnalate, tuttavia le ho postate, come detto, per "rincuorarti" circa l'Italia:
- nella tabella delle morti che comprende i suicidi, l'Italia è 126ma al mondo, per cui difficilmente, filtrando i suicidi, balzerà al secondo posto (ma andrebbe verificato, poiché il fatto che nel mondo il 21% delle morti da arma da fuoco sia un suicidio è informazione troppo vaga); ad esempio la Francia ha un valore di 3,24 contro l'1,35 dell'Italia e non sono sicuro ci siano abbastanza suicidi in Francia per poi farla addirittura retrocedere rispetto all'Italia
- nella tabella degli omicidi intenzionali, l'Italia è 175ma (ex aequo con altre quattro fra cui Cina e Svizzera) e anche qui non scommetterei (ma pur sempre ipotesi "a naso" è) che aggiungendo gli omicidi colposi e accidentali, togliendo quelli non con arma da fuoco, l'Italia salirebbe in seconda posizione (significherebbe che negli altri paesi si uccide estremamente poco con le armi e che noi italiani siamo drammaticamente imbranati nel maneggiare armi da fuoco).
- nella tabella delle morti che comprende i suicidi, l'Italia è 126ma al mondo, per cui difficilmente, filtrando i suicidi, balzerà al secondo posto (ma andrebbe verificato, poiché il fatto che nel mondo il 21% delle morti da arma da fuoco sia un suicidio è informazione troppo vaga); ad esempio la Francia ha un valore di 3,24 contro l'1,35 dell'Italia e non sono sicuro ci siano abbastanza suicidi in Francia per poi farla addirittura retrocedere rispetto all'Italia
- nella tabella degli omicidi intenzionali, l'Italia è 175ma (ex aequo con altre quattro fra cui Cina e Svizzera) e anche qui non scommetterei (ma pur sempre ipotesi "a naso" è) che aggiungendo gli omicidi colposi e accidentali, togliendo quelli non con arma da fuoco, l'Italia salirebbe in seconda posizione (significherebbe che negli altri paesi si uccide estremamente poco con le armi e che noi italiani siamo drammaticamente imbranati nel maneggiare armi da fuoco).
#671
Tematiche Culturali e Sociali / Re: Le morti per armi da fuoco in Italia!
23 Febbraio 2023, 17:27:56 PM
Mea culpa, ho citato due fonti, ma non le esatte tabelle a cui mi riferivo, una per ciascun link, ossia queste due (qui troncate per motivi di spazio, ma se scorrete in basso nei rispettivi siti troverete l'Italia):




#672
Tematiche Culturali e Sociali / Re: Le morti per armi da fuoco in Italia!
23 Febbraio 2023, 13:52:38 PMCitazione di: Eutidemo il 23 Febbraio 2023, 12:40:49 PMho scoperto con estrema "sorpresa" e "costernazione" che noi, in rapporto alla popolazione, siamo al secondo posto in classifica (dopo gli USA) quanto agli omicidi commessi con le armi da fuoco; precedendo, in questo triste primato, tutti gli altri Paesi europei.Provo a "rincuorarti" con statistiche più estese e più recenti; qui trovi dati più aggiornati, sebbene le morti riguardino anche i suicidi con arma da fuoco:
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gun-deaths-by-country
mentre questa è focalizzata sugli omicidi intenzionali con arma da fuoco:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_intentional_homicide_rate
#673
Tematiche Filosofiche / Re: Realtà e Verità
23 Febbraio 2023, 10:08:08 AMCitazione di: Alberto Knox il 23 Febbraio 2023, 00:47:16 AMvoglio ricavare un essenza di necessari e universali non solo nel mondo fisico (come le leggi fisiche) ma anche dell essere (percezione e intelletto)Per assecondare questo tuo volere, potresti partire, se non lo hai già fatto, dalla disputa medievale sugli universali: https://it.wikipedia.org/wiki/Disputa_sugli_universali
#674
Varie / Re: Il problemino della scacchiera
23 Febbraio 2023, 10:02:24 AM
Ritornando più in tema, qui vengono riassunti alcuni principi della gestalt:

Propongo inoltre anche questa immagine (che funziona meglio se aperta a tutto schermo in un'altra scheda del browser):
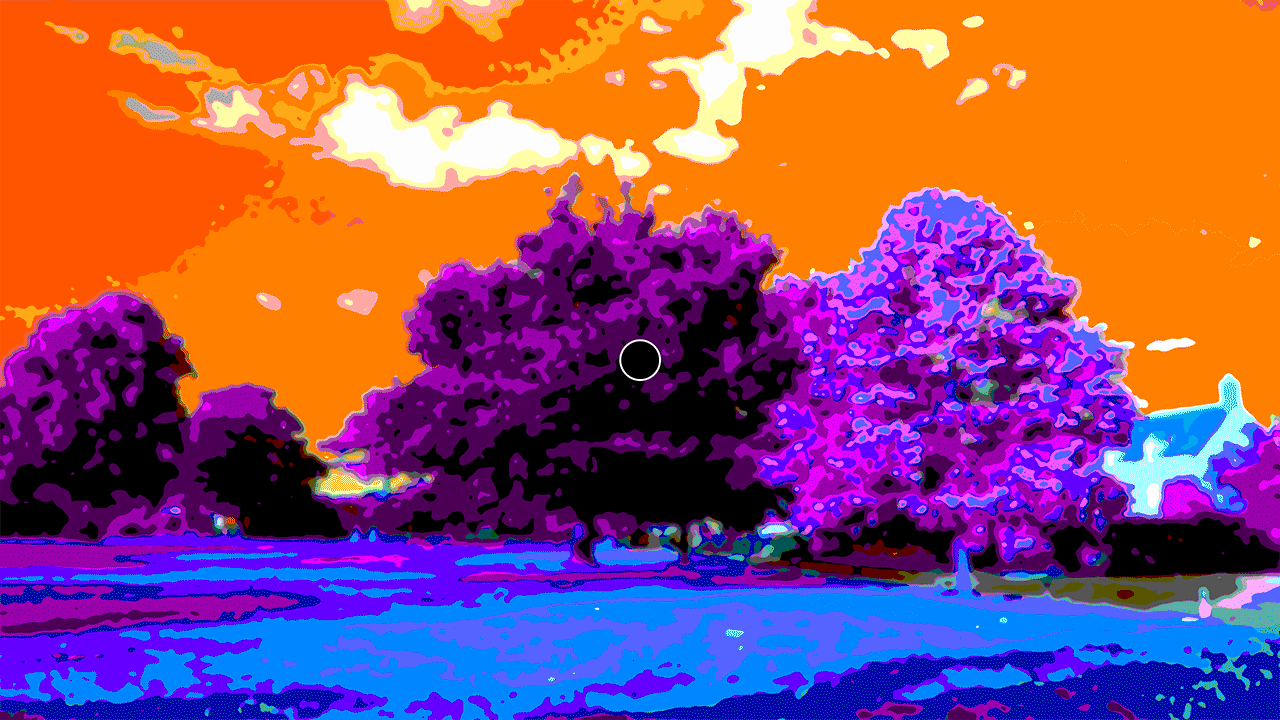
fissando il punto nero al centro, quando l'immagine (animata) diventerà in bianco e nero, finché non distoglieremo lo sguardo dal punto nero, il nostro cervello ci illuderà facendoci vedere perifericamente l'immagine con colori naturali.
Questa funziona allo stesso modo:


Propongo inoltre anche questa immagine (che funziona meglio se aperta a tutto schermo in un'altra scheda del browser):
fissando il punto nero al centro, quando l'immagine (animata) diventerà in bianco e nero, finché non distoglieremo lo sguardo dal punto nero, il nostro cervello ci illuderà facendoci vedere perifericamente l'immagine con colori naturali.
Questa funziona allo stesso modo:

#675
Varie / Re: Il problemino della scacchiera
22 Febbraio 2023, 21:11:58 PM
L'illusione, come la conoscenza, è una forma di relazione: fra aspettative e risultati (in politica, ma non solo), fra punti di vista (molti trucchi, in ogni campo, presuppongono un inganno di prospettiva), fra elementi che sembrano (illudendoci appunto) avere una certa relazione (di colore, ad esempio) invece ne hanno un'altra, etc.
In questi casi, mi piace ricordare che «illusione» deriva da in-ludere, che potrei maccheronicamente tradurre con «attrarre in un gioco», adescare in una realtà ambigua, in-gannare (etimo equivalente) mischiando realtà e finzione (come accade in tutti i giochi, nel momento in cui creano una loro dimensione ludica). L'illusione per rivelarsi tale, ha comunque bisogno del disincanto, di qualcosa di "oggettivo" che disilluda dalle aspettative e dalle apparenze; in questo caso è stato sufficiente un identificatore di colori, in altri casi l'"oggettività" è cosi caleidoscopica da essere sfuggente o così indecifrabile (forse proprio perché priva di "cifre") da essere un "Rorschach" (come dico spesso).
L'esempio dei colori è calzante: si tende a pensare che il colore appartenga all'oggetto, sia una sua proprietà, quando razionalmente sappiamo invece che il colore "appartiene" al cervello che guarda l'oggetto illuminato, non all'oggetto. Di notte gli oggetti cambiano colore (e diamo per scontato che il colore "vero" sia quello che hanno di giorno); per un daltonico o un altro animale l'oggetto ha un colore differente anche di giorno, ma in realtà tutto ciò accade perché l'oggetto non ha affatto un colore: ha solo una superficie che riflette la luce in un determinato modo ed è questa superficie a non cambiare mai, né di giorno, né di notte, né a seconda della luce né a seconda di chi la guarda (o se nessuno la guarda). Il colore dell'oggetto non esiste in esso intrinsecamente, noi ne vediamo solo la luce riflessa colorata per come il nostro cervello la elabora (queste illusioni della gestalt lo dimostrano). Il colore, come altre "realtà", è dunque tutto negli occhi (e più indietro) di chi guarda, al punto che guardandolo lo proietta prospetticamente sull'oggetto, vedendocelo.
Uscendo dal mondo dei colori (ma non troppo), la politica e la vita stessa (per come è spesso idealizzata) sono, a loro modo, illusione (nel senso di sovrastrutture ludico-estetiche) e ce ne accorgiamo se riusciamo ad "uscire dal gioco" per un attimo; per quanto siano indubbiamente un "gioco di società" così tentacolare, inculcato e omnipervasivo che è difficile non stare al gioco. Per questo alcuni, a suo tempo, seppero uscire dalla partita e dall'illusione solo con la scelta drastica dell'eremitaggio (in quanto riduzione delle relazioni, v. incipit).
In questi casi, mi piace ricordare che «illusione» deriva da in-ludere, che potrei maccheronicamente tradurre con «attrarre in un gioco», adescare in una realtà ambigua, in-gannare (etimo equivalente) mischiando realtà e finzione (come accade in tutti i giochi, nel momento in cui creano una loro dimensione ludica). L'illusione per rivelarsi tale, ha comunque bisogno del disincanto, di qualcosa di "oggettivo" che disilluda dalle aspettative e dalle apparenze; in questo caso è stato sufficiente un identificatore di colori, in altri casi l'"oggettività" è cosi caleidoscopica da essere sfuggente o così indecifrabile (forse proprio perché priva di "cifre") da essere un "Rorschach" (come dico spesso).
L'esempio dei colori è calzante: si tende a pensare che il colore appartenga all'oggetto, sia una sua proprietà, quando razionalmente sappiamo invece che il colore "appartiene" al cervello che guarda l'oggetto illuminato, non all'oggetto. Di notte gli oggetti cambiano colore (e diamo per scontato che il colore "vero" sia quello che hanno di giorno); per un daltonico o un altro animale l'oggetto ha un colore differente anche di giorno, ma in realtà tutto ciò accade perché l'oggetto non ha affatto un colore: ha solo una superficie che riflette la luce in un determinato modo ed è questa superficie a non cambiare mai, né di giorno, né di notte, né a seconda della luce né a seconda di chi la guarda (o se nessuno la guarda). Il colore dell'oggetto non esiste in esso intrinsecamente, noi ne vediamo solo la luce riflessa colorata per come il nostro cervello la elabora (queste illusioni della gestalt lo dimostrano). Il colore, come altre "realtà", è dunque tutto negli occhi (e più indietro) di chi guarda, al punto che guardandolo lo proietta prospetticamente sull'oggetto, vedendocelo.
Uscendo dal mondo dei colori (ma non troppo), la politica e la vita stessa (per come è spesso idealizzata) sono, a loro modo, illusione (nel senso di sovrastrutture ludico-estetiche) e ce ne accorgiamo se riusciamo ad "uscire dal gioco" per un attimo; per quanto siano indubbiamente un "gioco di società" così tentacolare, inculcato e omnipervasivo che è difficile non stare al gioco. Per questo alcuni, a suo tempo, seppero uscire dalla partita e dall'illusione solo con la scelta drastica dell'eremitaggio (in quanto riduzione delle relazioni, v. incipit).

