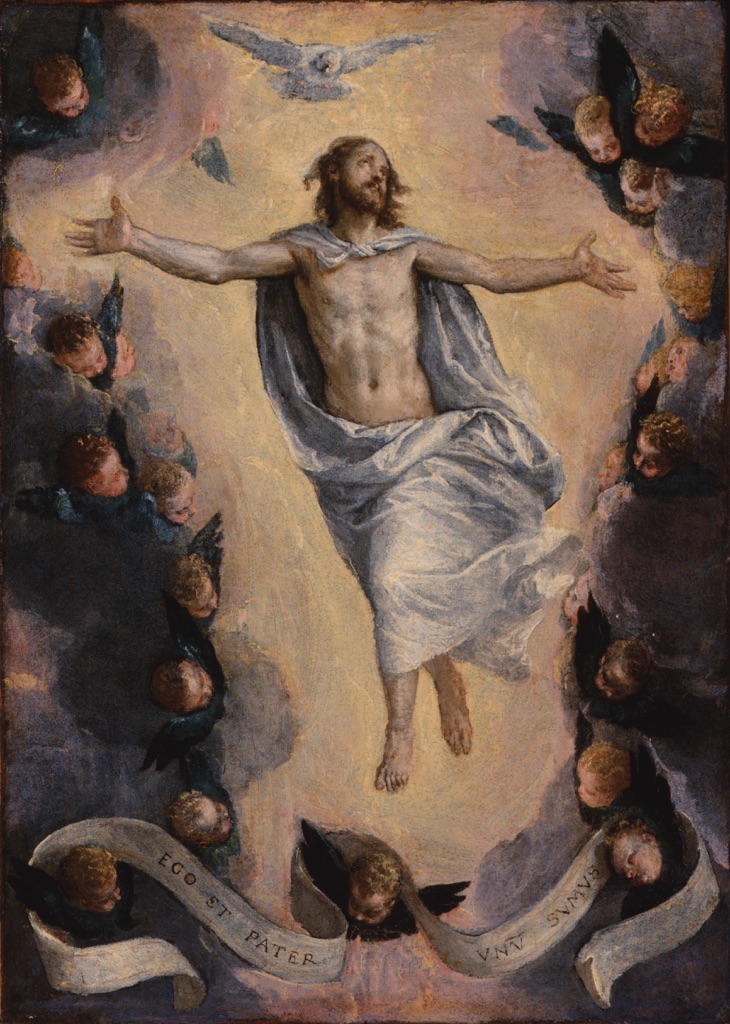Walt Whitman: "L'autunno"
Ecco è l'autunno.
D'un verde più cupo, più gialli e più rossi,
gli alberi rendono freschi e dolci i villaggi dell'Ohio,
con le foglie che tremolano a un mite vento,
le mele pendono mature nei frutteti,
pendono i grappoli dai pergolati
(avverti l'aroma dei grappoli sui tralci?
Senti l'odore del grano saraceno, dove testé ronzavano, le api?).
Su tutto s'apre il cielo,
così limpido e calmo dopo la pioggia, e con mirabili nubi;
anche al disotto è tutto calmo, pieno di vita, bello;
il podere è in fiore.
Ecco è l'autunno.
D'un verde più cupo, più gialli e più rossi,
gli alberi rendono freschi e dolci i villaggi dell'Ohio,
con le foglie che tremolano a un mite vento,
le mele pendono mature nei frutteti,
pendono i grappoli dai pergolati
(avverti l'aroma dei grappoli sui tralci?
Senti l'odore del grano saraceno, dove testé ronzavano, le api?).
Su tutto s'apre il cielo,
così limpido e calmo dopo la pioggia, e con mirabili nubi;
anche al disotto è tutto calmo, pieno di vita, bello;
il podere è in fiore.