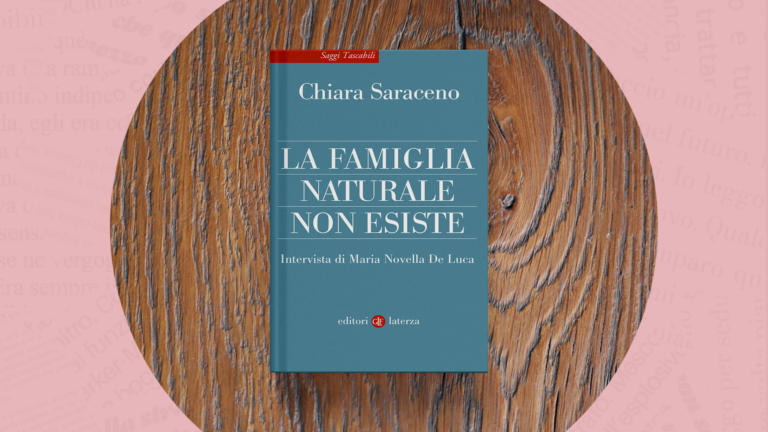Dal Vangelo di Matteo: "... a chiunque ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha" (25, 29).
L'effetto San Matteo, teorizzato dal sociologo Robert Merton, descrive come le persone che già godono di un vantaggio iniziale tendano ad accumulare sempre più vantaggi, mentre chi parte svantaggiato incontra difficoltà crescenti nel recuperare terreno. Questo fenomeno, chiamato anche "vantaggio cumulativo", si basa sull'idea che il successo genera altro successo, il ricco diventa più ricco, il povero più povero, creando un divario sempre maggiore tra chi ha e chi non ha.
In sociologia l'effetto San Matteo è un processo per cui, in certe situazioni, le nuove risorse che si rendono disponibili vengono ripartite fra i partecipanti in proporzione a quanto hanno già. In inglese questo viene espresso con la frase "the rich get richer and the poor get poorer" cioè: "i ricchi si arricchiscono sempre più, i poveri si impoveriscono sempre più".
Il divario si riferisce alla disparità nella distribuzione del reddito e della ricchezza tra le persone all'interno di una società. Questo fenomeno, evidente in ogni epoca, crea problemi per la stabilità sociale e l'uguaglianza delle opportunità.
Le cause del divario sono complesse e dipendono da molteplici fattori, tra cui la crescita economica ineguale, le politiche sociali inadeguate e gli svantaggi sociali ereditati.
La crescita economica ineguale è una delle cause più importanti del divario tra ricchi e poveri. Quando solo alcune parti della società beneficiano della crescita economica, questo può portare a un aumento delle disuguaglianze. Ad esempio, se le ricchezze sono concentrate nelle mani di pochi individui o aziende, questo può limitare le opportunità per le classi sociali più povere della società. Inoltre, può aumentare la criminalità e la tensione sociale.
Lo statunitense Cass Robert Sunstein, docente di diritto nell'Harvard Law School, nel suo libro titolato: "Come diventare famosi. La scienza segreta del successo", si chiede se l'effetto San Matteo sia sufficiente per spiegare il successo di un individuo: tale teoria funziona solo a posteriori, quando una persona è già affermata. Ma all'inizio ? Nei casi dei pochi privilegiati cosa ha innescato la valanga che mentre scende a valle aumenta di volume ?
L'autore analizza le informazioni che raccontano il successo di artisti, letterati o studiosi. Gli inneschi sono diversi, casuali, imprevedibili.
A Venezia il recente matrimonio-spettacolo tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez fa capire che nella vita tutto dipende da quanto si guadagna.
Tale "connubio", finto o vero che sia, quanto durerà ? Un anno, due...
L'effetto San Matteo, teorizzato dal sociologo Robert Merton, descrive come le persone che già godono di un vantaggio iniziale tendano ad accumulare sempre più vantaggi, mentre chi parte svantaggiato incontra difficoltà crescenti nel recuperare terreno. Questo fenomeno, chiamato anche "vantaggio cumulativo", si basa sull'idea che il successo genera altro successo, il ricco diventa più ricco, il povero più povero, creando un divario sempre maggiore tra chi ha e chi non ha.
In sociologia l'effetto San Matteo è un processo per cui, in certe situazioni, le nuove risorse che si rendono disponibili vengono ripartite fra i partecipanti in proporzione a quanto hanno già. In inglese questo viene espresso con la frase "the rich get richer and the poor get poorer" cioè: "i ricchi si arricchiscono sempre più, i poveri si impoveriscono sempre più".
Il divario si riferisce alla disparità nella distribuzione del reddito e della ricchezza tra le persone all'interno di una società. Questo fenomeno, evidente in ogni epoca, crea problemi per la stabilità sociale e l'uguaglianza delle opportunità.
Le cause del divario sono complesse e dipendono da molteplici fattori, tra cui la crescita economica ineguale, le politiche sociali inadeguate e gli svantaggi sociali ereditati.
La crescita economica ineguale è una delle cause più importanti del divario tra ricchi e poveri. Quando solo alcune parti della società beneficiano della crescita economica, questo può portare a un aumento delle disuguaglianze. Ad esempio, se le ricchezze sono concentrate nelle mani di pochi individui o aziende, questo può limitare le opportunità per le classi sociali più povere della società. Inoltre, può aumentare la criminalità e la tensione sociale.
Lo statunitense Cass Robert Sunstein, docente di diritto nell'Harvard Law School, nel suo libro titolato: "Come diventare famosi. La scienza segreta del successo", si chiede se l'effetto San Matteo sia sufficiente per spiegare il successo di un individuo: tale teoria funziona solo a posteriori, quando una persona è già affermata. Ma all'inizio ? Nei casi dei pochi privilegiati cosa ha innescato la valanga che mentre scende a valle aumenta di volume ?
L'autore analizza le informazioni che raccontano il successo di artisti, letterati o studiosi. Gli inneschi sono diversi, casuali, imprevedibili.
A Venezia il recente matrimonio-spettacolo tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez fa capire che nella vita tutto dipende da quanto si guadagna.
Tale "connubio", finto o vero che sia, quanto durerà ? Un anno, due...