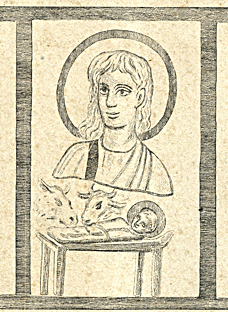/5
Nel 381 l'imperatore Teodosio I convocò il primo concilio di Costantinopoli, durante il quale fu riaffermato il Credo elaborato nel concilio di Nicea del 325.
Venne ribadita la consustanzialità dello Spirito Santo con il Padre e il Figlio, perciò fu detto "credo niceno-costantinopolitano". Inoltre, questo concilio aggiunse nel Credo il nome di Maria Vergine: [...] "Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, / e per opera dello Spirito Santo / si è incarnato nel seno della Vergine Maria / e si è fatto uomo".
La scelta di aggiungere il nome di Maria nel Credo pose le basi per le discussioni in un ulteriore concilio, quello di Efeso nel 431, per dibattere sulla natura della Madre di Dio: Maria è genitrice di Dio, la "Theotòkos", perché ha fatto nascere non un uomo ma Dio come uomo.
Nel Concilio di Efeso fu anche affrontato un aspro dibattito che minacciava l'unità della Chiesa cristiana, riguardante la persona e la divinità di Gesù. Si confrontarono due ideologie: quella antiochena, capeggiata dal patriarca Nestorio e quella alessandrina, con a capo Cirillo di Alessandria d'Egitto.
Nestorio e i suoi seguaci sostenevano che Gesù Cristo avesse due nature: umana e divina, non unite nel vincolo ipostatico, invece Cirillo era convinto della sola natura divina di Cristo.
Connessa alla disputa su Gesù Cristo, vi era quella collegata all'appellativo Theotòkos dato alla madre di Gesù. I nestoriani affermavano che Maria fosse solamente Christotokos, madre di Gesù-Uomo e non Madre di Dio, che accolse in sé, con l'Uomo-Messia anche il Figlio di Dio unito all'Uomo.
Altro concilio, quello di Calcedonia nel 451, convocato per dibattere le dispute ideologiche sulle due nature di Gesù, quella umana e quella divina....
Nel 553 ci fu il secondo concilio di Costantinopoli per definire la "verginità perpetua di Maria": vergine prima, durante e dopo la nascita di Gesù.
La verginità durante la nascita di Gesù è conseguenza logica (dogmatica) dell'incarnazione di Gesù Cristo nel grembo di Maria per opera dello Spirito Santo, affermata nel prologo del Vangelo di Giovanni (1, 1-18) e nel Credo.
La dottrina della Verginità (perpetua) di Maria prima, durante e dopo il parto fu riaffermata nel 649 dal concilio lateranense, cosiddetto perché svolto a Roma nella basilica di San Giovanni in Laterano e presieduto dal pontefice Martino I.
Non basta. La verginità perpetua di Maria fu ribadita ancora una volta nel 680 dal III concilio di Costantinopoli.
Cosa dedurre dal travagliato problema del concepimento verginale di Gesù da parte di Maria, avvenuto per volontà divina ?
Ogni religione ha bisogno di stupire i propri seguaci.
La dottrina della verginità è sostenuta dalla Chiesa cattolica e ortodossa come verità di fede invece alcune Chiese protestanti pur ammettendo il concepimento verginale di Gesù in Maria, non le riconoscono la verginità perpetua, perché credono che Maria e Giuseppe abbiano avuto altri figli dopo la nascita di Gesù.
Nel 381 l'imperatore Teodosio I convocò il primo concilio di Costantinopoli, durante il quale fu riaffermato il Credo elaborato nel concilio di Nicea del 325.
Venne ribadita la consustanzialità dello Spirito Santo con il Padre e il Figlio, perciò fu detto "credo niceno-costantinopolitano". Inoltre, questo concilio aggiunse nel Credo il nome di Maria Vergine: [...] "Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, / e per opera dello Spirito Santo / si è incarnato nel seno della Vergine Maria / e si è fatto uomo".
La scelta di aggiungere il nome di Maria nel Credo pose le basi per le discussioni in un ulteriore concilio, quello di Efeso nel 431, per dibattere sulla natura della Madre di Dio: Maria è genitrice di Dio, la "Theotòkos", perché ha fatto nascere non un uomo ma Dio come uomo.
Nel Concilio di Efeso fu anche affrontato un aspro dibattito che minacciava l'unità della Chiesa cristiana, riguardante la persona e la divinità di Gesù. Si confrontarono due ideologie: quella antiochena, capeggiata dal patriarca Nestorio e quella alessandrina, con a capo Cirillo di Alessandria d'Egitto.
Nestorio e i suoi seguaci sostenevano che Gesù Cristo avesse due nature: umana e divina, non unite nel vincolo ipostatico, invece Cirillo era convinto della sola natura divina di Cristo.
Connessa alla disputa su Gesù Cristo, vi era quella collegata all'appellativo Theotòkos dato alla madre di Gesù. I nestoriani affermavano che Maria fosse solamente Christotokos, madre di Gesù-Uomo e non Madre di Dio, che accolse in sé, con l'Uomo-Messia anche il Figlio di Dio unito all'Uomo.
Altro concilio, quello di Calcedonia nel 451, convocato per dibattere le dispute ideologiche sulle due nature di Gesù, quella umana e quella divina....
Nel 553 ci fu il secondo concilio di Costantinopoli per definire la "verginità perpetua di Maria": vergine prima, durante e dopo la nascita di Gesù.
La verginità durante la nascita di Gesù è conseguenza logica (dogmatica) dell'incarnazione di Gesù Cristo nel grembo di Maria per opera dello Spirito Santo, affermata nel prologo del Vangelo di Giovanni (1, 1-18) e nel Credo.
La dottrina della Verginità (perpetua) di Maria prima, durante e dopo il parto fu riaffermata nel 649 dal concilio lateranense, cosiddetto perché svolto a Roma nella basilica di San Giovanni in Laterano e presieduto dal pontefice Martino I.
Non basta. La verginità perpetua di Maria fu ribadita ancora una volta nel 680 dal III concilio di Costantinopoli.
Cosa dedurre dal travagliato problema del concepimento verginale di Gesù da parte di Maria, avvenuto per volontà divina ?
Ogni religione ha bisogno di stupire i propri seguaci.
La dottrina della verginità è sostenuta dalla Chiesa cattolica e ortodossa come verità di fede invece alcune Chiese protestanti pur ammettendo il concepimento verginale di Gesù in Maria, non le riconoscono la verginità perpetua, perché credono che Maria e Giuseppe abbiano avuto altri figli dopo la nascita di Gesù.