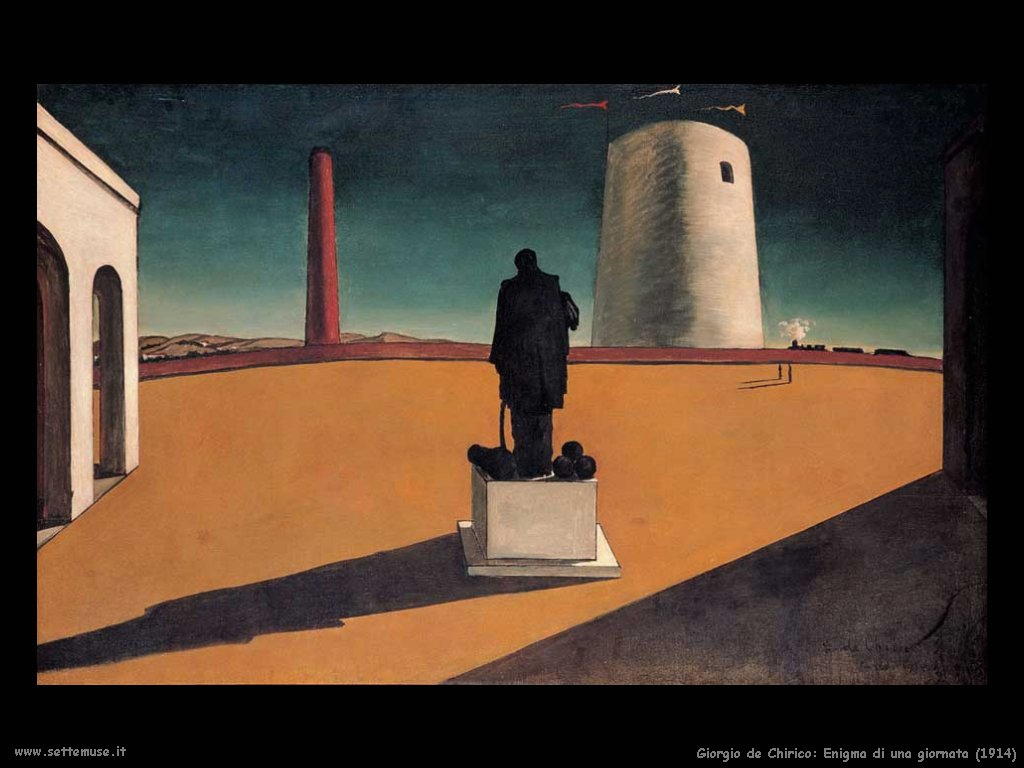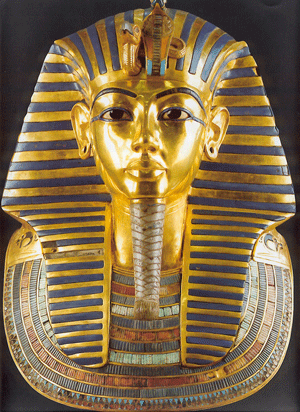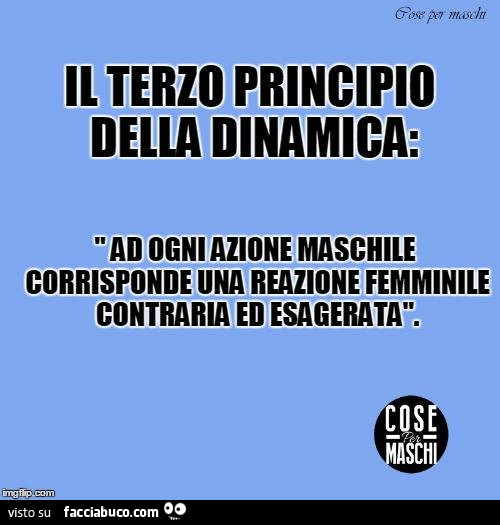/2
Il giardino curtense era anche uno dei luoghi per manifestare l'amor cortese, simboleggiato dalla rosa, che può rappresentare in modo ambivalente sia l'amore passionale sia la verginità, l'elevazione spirituale e la vanità.
Ma chi è degno di amore ? Come amare ?
Lo scrittore e religioso francese André le Chapelain (1150 circa – 1220 circa) conosciuto in Italia con nome e cognome italianizzati "Andrea Cappellano", visse nel periodo in cui nasceva e veniva diffusa la lirica cortese.
Non si hanno notizie certe sulla sua vita. Gli studiosi ipotizzano che sia stato cappellano alla corte di Maria di Champagne, figlia di Luigi VII e della regina Eleonora d'Aquitania.
Andrea fu autore del "De amore", un trattato scritto in latino medievale nel 1185 circa, suddiviso in tre volumi, in cui si indicano i precetti principali dell'amor cortese:
1. il vassallaggio nel rapporto d'amore e la relativa subordinazione del cavaliere alla sua dama.ù
2. Il vero rapporto amoroso è extramatrimoniale. L'amor cortese è superiore all'amore coniugale.
Scrisse il "De amore" su richiesta del suo amico Gualtieri, che non sa "aconciamente direggiere li freni di quel cavallo".
Nella prima parte del suo trattato Cappellano affronta i problemi amorosi da un punto di vista aristocratico e laico, cominciando col dire cos'è l'amore e le regole d'amore; nella seconda, sostiene "che niuno dee ispendere male i suoi dì nell'amore" e che voler realizzare tutti i desideri del corpo porta "fuori della grazia di Dio e della compagnia e dell'amistà de' buoni uomini".
Nei primi due libri Andrea riteneva che l'amore coniugale fosse inferiore perché risentiva dei doveri e delle responsabilità del matrimonio e perché diventava scontato per i due coniugi.
Ma in quel tempo la sua opinione sull'amore (basata sulla sessualità) era pericolosa, perché distante dall'amore cortese, considerato spirituale. Perciò nel suo terzo libro del "De Amore" dovette fare uso della reprobatio amoris, con cui egli si pose contro l'amore e la donna, indicata con parole "sconce". Forse ricevette minacce di morte per ciò che aveva scritto nei primi due libri e si convertì all'idea della superiorità dell'amore coniugale., che può essere valorizzato con il rispetto e quindi con concetti diversi dall'adulterio.
Le ragioni della contraddizione ? Il timore di essere condannato come eretico. La contraddizione svela "le inquietudini di una cultura che era insieme laica e clericale, spregiudicata e rispettosa dell'ordine sociale".
Nel De Amore c'è anche il tentativo di Andrea separare il sacro dal profano (i capitoli XIX e XX sono rispettivamente dedicati all'amore dei chierici e all'amore delle monache) e di voler "amaestrare con iscrittura"; pone il saper bene parlare come uno dei modi più importanti - insieme alla bellezza e "ai belli costumi".
Ma nel 1277, "il vescovo di Parigi, Stefano Tempier, facendo seguito a una bolla di papa Giovanni XXI, pronunciò contro il libro di Andrea Cappellano una solenne condanna; la Chiesa capiva l'influenza sociale del "De Amore", considerato la codificazione dei rapporti non solo amorosi ma etici e sociali della società aristocratica "progressista" francese, che ebbe notevole influenza sulla formazione ideologica della nascente borghesia.
Nel 1215 durante il IV Concilio lateranense la Chiesa regolamentò il sacramento della penitenza e rese obbligatoria la confessione annuale per sapere la "verità" dei peccatori e, al contempo, facendo del sesso la "materia privilegiata di confessione".
Il giardino curtense era anche uno dei luoghi per manifestare l'amor cortese, simboleggiato dalla rosa, che può rappresentare in modo ambivalente sia l'amore passionale sia la verginità, l'elevazione spirituale e la vanità.
Ma chi è degno di amore ? Come amare ?
Lo scrittore e religioso francese André le Chapelain (1150 circa – 1220 circa) conosciuto in Italia con nome e cognome italianizzati "Andrea Cappellano", visse nel periodo in cui nasceva e veniva diffusa la lirica cortese.
Non si hanno notizie certe sulla sua vita. Gli studiosi ipotizzano che sia stato cappellano alla corte di Maria di Champagne, figlia di Luigi VII e della regina Eleonora d'Aquitania.
Andrea fu autore del "De amore", un trattato scritto in latino medievale nel 1185 circa, suddiviso in tre volumi, in cui si indicano i precetti principali dell'amor cortese:
1. il vassallaggio nel rapporto d'amore e la relativa subordinazione del cavaliere alla sua dama.ù
2. Il vero rapporto amoroso è extramatrimoniale. L'amor cortese è superiore all'amore coniugale.
Scrisse il "De amore" su richiesta del suo amico Gualtieri, che non sa "aconciamente direggiere li freni di quel cavallo".
Nella prima parte del suo trattato Cappellano affronta i problemi amorosi da un punto di vista aristocratico e laico, cominciando col dire cos'è l'amore e le regole d'amore; nella seconda, sostiene "che niuno dee ispendere male i suoi dì nell'amore" e che voler realizzare tutti i desideri del corpo porta "fuori della grazia di Dio e della compagnia e dell'amistà de' buoni uomini".
Nei primi due libri Andrea riteneva che l'amore coniugale fosse inferiore perché risentiva dei doveri e delle responsabilità del matrimonio e perché diventava scontato per i due coniugi.
Ma in quel tempo la sua opinione sull'amore (basata sulla sessualità) era pericolosa, perché distante dall'amore cortese, considerato spirituale. Perciò nel suo terzo libro del "De Amore" dovette fare uso della reprobatio amoris, con cui egli si pose contro l'amore e la donna, indicata con parole "sconce". Forse ricevette minacce di morte per ciò che aveva scritto nei primi due libri e si convertì all'idea della superiorità dell'amore coniugale., che può essere valorizzato con il rispetto e quindi con concetti diversi dall'adulterio.
Le ragioni della contraddizione ? Il timore di essere condannato come eretico. La contraddizione svela "le inquietudini di una cultura che era insieme laica e clericale, spregiudicata e rispettosa dell'ordine sociale".
Nel De Amore c'è anche il tentativo di Andrea separare il sacro dal profano (i capitoli XIX e XX sono rispettivamente dedicati all'amore dei chierici e all'amore delle monache) e di voler "amaestrare con iscrittura"; pone il saper bene parlare come uno dei modi più importanti - insieme alla bellezza e "ai belli costumi".
Ma nel 1277, "il vescovo di Parigi, Stefano Tempier, facendo seguito a una bolla di papa Giovanni XXI, pronunciò contro il libro di Andrea Cappellano una solenne condanna; la Chiesa capiva l'influenza sociale del "De Amore", considerato la codificazione dei rapporti non solo amorosi ma etici e sociali della società aristocratica "progressista" francese, che ebbe notevole influenza sulla formazione ideologica della nascente borghesia.
Nel 1215 durante il IV Concilio lateranense la Chiesa regolamentò il sacramento della penitenza e rese obbligatoria la confessione annuale per sapere la "verità" dei peccatori e, al contempo, facendo del sesso la "materia privilegiata di confessione".