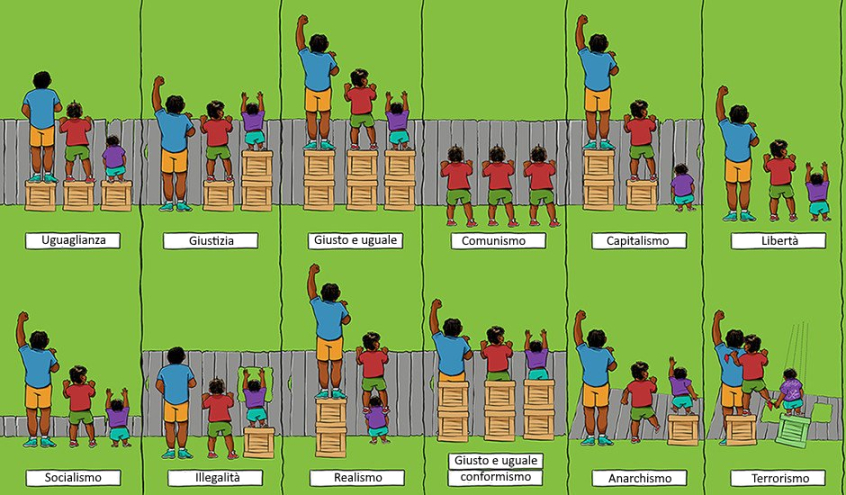Per come la vedo, le (dis)avventure storiche del principio di individuazione sembrano suggerire che il fondamento di ogni logica, ovvero il principio di identità (a=a), sia una questione il cui contenuto esperienziale riguarda più l'interpretazione (decifrazione) umana del mondo che il mondo stesso (partendo da tale consapevolezza, alcune filosofie orientali, spesso fraintese come ontologie, parlano di «nulla» e non di «noumeno», di «non-discriminazione» e non di «Verità», etc.). Una volta (im)poste le categorie (fra cui quella stessa di «esistenza»...) che denotano un sistema (sulla cui aporetica completezza e coerenza Gödel ha dato spunti cruciali, come già segnalato da altro topic), il sistema interpreta il reale, lo frammenta in identità (a=a, b=b, etc.) "ragionabili" e manipolabili, potendo poi produrre cambiamenti, invenzioni, scoperte e conoscenze sempre più minuziosi nelle dimensioni e grandiosi nella portata gnoseologica (proprio come, una volta "impostata" una lingua ci si possono produrre poesie, poemi, enciclopedie, etc. sobillare rivoluzioni, stilare dichiarazioni universali, etc.).
Essendo l'uomo un animale tanto pragmatico quanto semantico, il costante sviluppo di ulteriori prassi tecnologiche e l'aggregarsi di nuovi significati ne scandiscono la storia, tuttavia il punto di partenza, della logica e dei discorsi in generale, resta sempre il "riempimento sostanziale" di quel a=a, da cui si inizia a ragionare, esperire (o meglio, decifrare le percezioni) e conoscere (oltre che, parlando di valori in tutti i sensi, giudicare).
Il non sapere non presuppone la possibilità di sapere: ci sono non-saperi che non possono essere risolti da un sapere, come tutti quelli connessi alle domande malposte o prive di senso o concretamente, appunto, impossibili da rispondere veridicamente appellandosi ad un sapere (come ad esempio «farò colazione domani?»; potrei non arrivarci, quindi... non lo so). Il non sapere presuppone la domanda sul sapere: solo dopo la domanda, si può affermare se «si sa» o «non si sa» (uso volutamente l'impersonale, anche se il sapere è individuale); e la domanda prima di tutto identifica e denomina il suo oggetto (a=a), circa il quale si può avere conoscenza o meno. Ad esempio: guardando una nave, si può chiedere (mio solito esempio): «ti piace la polena?»; la prima reazione a questa domanda è cercare nel proprio "dizionario mentale" «polena»; una volta trovato, ovvero saputo, ciò che una polena è, dopo aver poi rintracciato ciò che permette di identificarlo (a=a) nel campo visivo, si può giudicarne la bellezza. Viceversa, mi accorgo di non sapere cos'è una polena solo dopo che ne ho incontrato il nome, e la domanda che lo contiene. So, guardando la nave, di avere di fronte a me una polena (almeno se mi fido della domanda del mio interlocutore), so che la vedo, ma non so quale spicchio di campo visivo la racchiuda, quale frammento di realtà la identifichi; so di non saperla identificare (ogni non sapere è in realtà un non saperlo, c'è sempre un "oggetto" in gioco, per quanto astratto e vago).
Resta chiaro che è il nome ad "aver bisogno" dell'identità del referente, non viceversa: nel momento in cui identifico qualcosa, distinguendolo dallo sfondo della realtà circostante, dargli un nome è solo una necessità comunicativa e pragmatica, non una necessità onto-logica (posso infatti chiamarlo con una sola lettera o con un nome di fantasia o denotarlo con quello», magari per domandare: «cos'è quello?»). Ad esempio, quando vedo una foto che rappresenta qualcosa che non conosco, ma chiaramente identificabile (a differenza di quando parto da un nome che non conosco, come «polena», di cui non so identificare il referente), ad esempio un misterioso oggetto appeso in una teca di vetro, nel momento in cui identifico quel qualcosa (a=a), posso, senza "battezzarlo", iniziare comunque a studiarlo, ragionarci, procedere nel definirlo per somiglianze e differenza con altri oggetti, etc. pur sapendo che in realtà quell'oggetto è perlopiù un insieme macroscopico di altri sotto-oggetti, fino agli atomi ed oltre.
Essendo l'uomo un animale tanto pragmatico quanto semantico, il costante sviluppo di ulteriori prassi tecnologiche e l'aggregarsi di nuovi significati ne scandiscono la storia, tuttavia il punto di partenza, della logica e dei discorsi in generale, resta sempre il "riempimento sostanziale" di quel a=a, da cui si inizia a ragionare, esperire (o meglio, decifrare le percezioni) e conoscere (oltre che, parlando di valori in tutti i sensi, giudicare).
Il non sapere non presuppone la possibilità di sapere: ci sono non-saperi che non possono essere risolti da un sapere, come tutti quelli connessi alle domande malposte o prive di senso o concretamente, appunto, impossibili da rispondere veridicamente appellandosi ad un sapere (come ad esempio «farò colazione domani?»; potrei non arrivarci, quindi... non lo so). Il non sapere presuppone la domanda sul sapere: solo dopo la domanda, si può affermare se «si sa» o «non si sa» (uso volutamente l'impersonale, anche se il sapere è individuale); e la domanda prima di tutto identifica e denomina il suo oggetto (a=a), circa il quale si può avere conoscenza o meno. Ad esempio: guardando una nave, si può chiedere (mio solito esempio): «ti piace la polena?»; la prima reazione a questa domanda è cercare nel proprio "dizionario mentale" «polena»; una volta trovato, ovvero saputo, ciò che una polena è, dopo aver poi rintracciato ciò che permette di identificarlo (a=a) nel campo visivo, si può giudicarne la bellezza. Viceversa, mi accorgo di non sapere cos'è una polena solo dopo che ne ho incontrato il nome, e la domanda che lo contiene. So, guardando la nave, di avere di fronte a me una polena (almeno se mi fido della domanda del mio interlocutore), so che la vedo, ma non so quale spicchio di campo visivo la racchiuda, quale frammento di realtà la identifichi; so di non saperla identificare (ogni non sapere è in realtà un non saperlo, c'è sempre un "oggetto" in gioco, per quanto astratto e vago).
Resta chiaro che è il nome ad "aver bisogno" dell'identità del referente, non viceversa: nel momento in cui identifico qualcosa, distinguendolo dallo sfondo della realtà circostante, dargli un nome è solo una necessità comunicativa e pragmatica, non una necessità onto-logica (posso infatti chiamarlo con una sola lettera o con un nome di fantasia o denotarlo con quello», magari per domandare: «cos'è quello?»). Ad esempio, quando vedo una foto che rappresenta qualcosa che non conosco, ma chiaramente identificabile (a differenza di quando parto da un nome che non conosco, come «polena», di cui non so identificare il referente), ad esempio un misterioso oggetto appeso in una teca di vetro, nel momento in cui identifico quel qualcosa (a=a), posso, senza "battezzarlo", iniziare comunque a studiarlo, ragionarci, procedere nel definirlo per somiglianze e differenza con altri oggetti, etc. pur sapendo che in realtà quell'oggetto è perlopiù un insieme macroscopico di altri sotto-oggetti, fino agli atomi ed oltre.
Citazione di: daniele22 il 10 Giugno 2021, 13:43:49 PMSolitamente si chiede anzitutto ascolto; il prerequisito del senso del parlare, inteso come comunicare, è l'avere un destinatario in ascolto (l'onanismo del soliloquio è il surrogato di una comunicazione autentica, è la dissimulazione della nostalgia di un destinatario mancante). Per dirla più filosoficamente: ogni domanda è preceduta logicamente dalla metadomanda circa le condizioni di possibilità di ottenere una risposta o, appunto, almeno ascolto.
quando ti rivolgi a qualcuno, più che l'apparente contingenza che ti farà dire quel che dirai, dovresti indagare il motivo più intimo che ti ha fatto rivolgere a quel qualcuno ... Intendo con ciò che quando cominci a parlare stai già chiedendo qualcosa anche senza chiedere. Cosa chiedi dunque, a prescindere da ciò che dici?