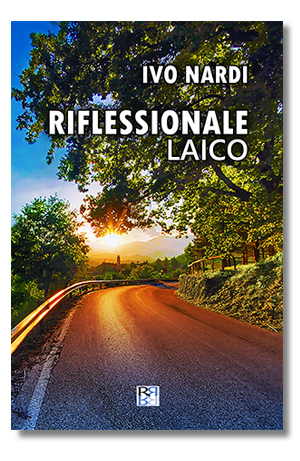Prefazione di Roberto Taioli
tratta dal libro: RIFLESSIONALE LAICO di Ivo Nardi
Riflessionale è un termine non presente nel dizionario della lingua italiana, ma dà il titolo al libro di Ivo Nardi, ove tale termine è declinato con svariate sfaccettature.
Riflessionale è l’anima del libro e compare esplicito o sotto traccia in tutti i capitoli.
All’esordio Nardi tenta di dargli una definizione, consapevole di quanto sfuggente e liquida sia la pretesa di inquadrarlo. “Riflessionale è un termine che ho coniato per descrivere uno spazio, reale o immaginato, dedicato all’ascolto interiore e al pensiero profondo. Una parola assente nei dizionari, nata dall’esigenza di dare un nome a quei momenti in cui ci si raccoglie per interrogarsi, ritrovare sé stessi e riscoprire il valore generativo del dubbio”.
Bisogna quindi scavare tra le pagine per reperire, di volta in volta, la sfumatura che l’autore conferisce a questa espressione e come vuole declinarla.
Ma l’autore ci fa da guida, ogni capitolo si apre con un incipit vissuto, collocato nel tempo dell’infanzia e dell’adolescenza e nei luoghi amati della nascita, nella Valle Roveto, tra Abruzzo e Lazio. Queste pagine contengono un ricchissimo lascito memoriale, un deposito proustiano, che affascina il lettore trovandosi davanti alle radici profonde e incancellabili di una storia che si trasforma, ma non rinuncia a collegarsi a quell’humus. Niente va perduto nella nostra vita, di cominciamento in cominciamento, riprendiamo il cammino, ma sempre dentro un “noi” che si trasforma e rilancia. Siamo sempre interi perché in noi coesistono, come in un tutto inscindibile, quello che siamo stati e che abbiamo fatto, e di cui conserviamo solo le memorie. Nel labirinto del nostro io interagiscono come in un intreccio tutte le nostre storie, dalle più remote alle più recenti, in una simbiosi che può a tratti anche far paura ma che ha qualcosa di meraviglioso.
Nardi nel suo libro abborda tanti lati del riflessionale, con l’aiuto della sapienza di filosofi che emergono in fulminei lampi di illuminazione. Il tema della mortalità, da la quale nullo homo vivente può scappare, come scrive San Francesco nel Cantico, è introdotto da un episodio di vita vissuta nell’estasi della campagna congeniale all’autore: “C’è un’immagine del passato che non si è mai dissolta, un ricordo che ancora respira nella mia mente, vivido nei dettagli e nelle emozioni. Mi trovavo seduto sul bordo di un vecchio fontanile costruito per abbeverare il bestiame. La vasca, con i suoi bordi bassi e consunti dal tempo, aveva il fondale ricoperto di fluttuanti erbe acquatiche che ondeggiavano come lunghi capelli, tingendo l’acqua di verdi cangianti, ora profondi come giada, ora lucenti come smeraldo. L’acqua, che proveniva da una sorgente non molto lontana, fuoriusciva da una cannella di ferro provocando un costante e morbido borbottio. Quel giorno, quel luogo pareva esistere solo per essere ammirato.
La luce del sole, che stava per nascondersi dietro la montagna, esaltava il profilo dell’alto campanile poco distante, immergendolo in un crescendo di colori. Prima un arancione caldo, poi il viola profondo, infine il blu del crepuscolo. Poco alla volta, le prime stelle cominciavano ad accendersi, una ad una. Era un momento di silenziosa armonia, in cui percepivo la sinfonia di tutte le cose convergere verso una sola direzione, in un unico verso, nell’unicità dell’universo.
Mi resi conto di come il tempo stesse cambiando davanti ai miei occhi: il giorno diventava notte, e sapevo che quella notte, che sembrava infinita, avrebbe lasciato posto a un nuovo giorno. Era un ciclo inevitabile, continuo, ma mai uguale a sé stesso. In quell’istante sentii il legame profondo tra il tempo, la vita e la morte, come se ogni attimo che scivolava via fosse un richiamo gentile alla nostra transitorietà. La transitorietà non è solo la fine delle cose, ma anche il loro divenire; è il continuo trasformarsi della vita, un movimento che ci ricorda come nulla rimanga immutato, nemmeno noi. È questa impermanenza che dà valore agli istanti, come un tramonto che apprezziamo proprio perché sappiamo che non durerà”.
Questo brano induce Nardi ad una riflessione sulla morte e al tema dell’impermanenza e ad Epicuro, il filosofo antico che ci ha insegnato ad affrontarla. Per Epicuro la morte paradossalmente non esiste perché quando noi viviamo, essa non c’è e quando sopraggiunge non ci siamo più noi. Ma l’impermanenza non è la fine di tutte le cose, è la loro trasformazione, il passaggio ad altro. Nulla permane, ma qualcosa sempre resta e nulla va perduto. Nulla è eterno ma possiamo, mediante la ripresentificazione, far sì che il presente conservi significato e riviva nel nuovo. Anche quando la famiglia si trasferisce a Roma, il giovane Ivo avverte un senso di perdita, di smarrimento, venendogli meno luoghi familiari che sono proprie della nostra infanzia e adolescenza. Ma la riflessione avrà poi col tempo interiorizzati quei luoghi tanto amati da farli diventare parte di sé stesso. Non perduti, ma sublimati. Esiste quindi sempre una sedimentazione che opera in noi e all’esterno di noi e che sotto traccia ci riconnette alla nostra e alle nostre storie individuali. Non siamo mai indivisi, lacerati, ma conserviamo nel mutamento tutte le tracce di noi e degli altri che abbiamo conosciuto. Formiamo una comunità spirituale che non ci abbandona e ognuno di noi, pur nella sua finitezza e irripetibilità, è il punto di arrivo e di ripartenza di una nuova catena.
Anche in altri luoghi del suo libro Nardi parla del dolore e della morte che scandiscono la nostra condizione umana. Se fossimo immortali non ci sarebbe più vita, scoperta, verità. Così ricorda il momento della morte della madre: “Rifletto ora sulla forza universale dei riti, siano essi religiosi o laici: i riti funebri hanno il potere di dare una forma al dolore, di incanalarlo, di offrirgli una direzione. Essi creano significato attorno alla perdita, rendendola parte di un ciclo più ampio, e aiutano a integrare il ricordo del defunto nella vita di chi resta”.
In questa correlazione universale permanenza e impermanenza si intrecciano misteriosamente: È sì vero, come scriveva Eraclito, che non ci si bagna mai nello stesso fiume perché, panta rei, tutto scorre,ma resta il greto di quel fiume ove per millenni l’acqua ha solcato il letto, cosicché, se guardiamo, tutto ci resta come se fosse rimasto intatto. Non è una illusione visiva, ma l’esito del lavoro incessante della natura.
Il Riflessionale è sì allora anche un “atto di cura”. “È la capacità di trasformare il pensiero in bellezza, di dare forma alla meraviglia. È la parola che nasce dopo l’ascolto, il senso che emerge dal silenzio”.
I sensi, pur fondamentali, ci ingannano, se non riusciamo ad andare oltre di essi, allargandone la prospettiva e l’energia nella nostra coscienza.
Roberto Taioli
Roberto Taioli, nato a Milano nel 1949 ha studiato filosofia con Enzo Paci. Membro della SIE - Società Italiana di Estetica, è cultore di Estetica presso l'Università Cattolica di Milano. Il suo campo di ricerca si situa all'interno dell'orizzonte fenomenologico. Ha pubblicato saggi su Merleau-Ponty, Husserl, Kant, Paci e altri autori significativi del '900.
Negli ultimi tempi ha orientato la sua ricerca verso la fenomenologia del sacro e del religioso e dell'estetica. Risalgono a questo versante i saggi su Raimon Panikkar e Cristina Campo.
Tra le suo opere: La pietra e il sogno, edizioni Stylos (Aosta); AA. VV. Appassionate distanze. Letture di Cristina Campo, a cura di M. Farneti, F. Secchieri, R. Taioli, Edizioni Tre Lune, Mantova; Il mistero del Piacatrix, Edizioni Rebis, Viareggio; Sul diario fenomenologico di Enzo Paci, Pianeta filosofia, e le plaquette di poesia: Segnavia, Bok Editore, Parma; e per le Edizioni Ulivo, Balerna (CH): Ciclo di Ayas; Altobosco; Acque a Cortod; Colligite fragmenta; Natura naturans; Ascendit. Poema alpino.
Su Amazon anche in versione eBook
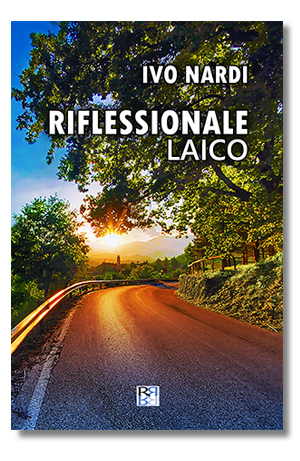
di Ivo Nardi
Su Amazon anche in versione eBook |