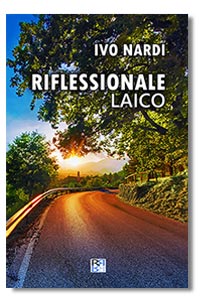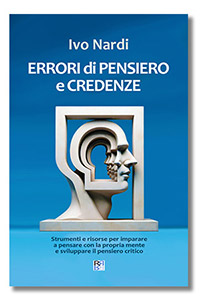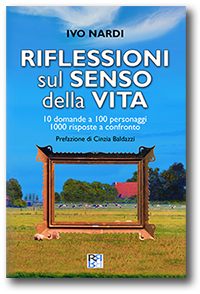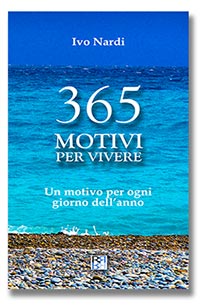Riflessioni in forma di conversazioni
di Doriano Fasoli
Interviste a personaggi della cultura italiana e straniera - Indice
Città di parole
Conversazione con Alessandro Portelli
di Doriano Fasoli per Riflessioni.it
- maggio 2006
Libri pubblicati da Riflessioni.it
RIFLESSIONI SUL SENSO DELLA VITA 365 MOTIVI PER VIVERE |
|
 Sono molti anni che il Circolo Gianni Bosio, e io personalmente, raccogliamo storie e forme espressive orali su queste parti di Roma. Già nel 1970 avevamo prodotto un disco di interviste e canzoni sulle lotte per la casa a partire dal Borghetto Prenestino e dall’Acquedotto Felice; poi, qualche tempo dopo, abbiamo curato un libro sulla storia del Borgo ragazzi di Don Bosco, l’istituzione salesiana che sta al Prenestino (il libro è stato tradotto anche in Brasile). Così è stato naturale continuare la ricerca, e quando Elisabetta Aloisi, assessore alla cultura del Municipio Roma VII, ci ha proposto un progetto abbiamo subito accettato e siamo partiti con le interviste.
Sono molti anni che il Circolo Gianni Bosio, e io personalmente, raccogliamo storie e forme espressive orali su queste parti di Roma. Già nel 1970 avevamo prodotto un disco di interviste e canzoni sulle lotte per la casa a partire dal Borghetto Prenestino e dall’Acquedotto Felice; poi, qualche tempo dopo, abbiamo curato un libro sulla storia del Borgo ragazzi di Don Bosco, l’istituzione salesiana che sta al Prenestino (il libro è stato tradotto anche in Brasile). Così è stato naturale continuare la ricerca, e quando Elisabetta Aloisi, assessore alla cultura del Municipio Roma VII, ci ha proposto un progetto abbiamo subito accettato e siamo partiti con le interviste.