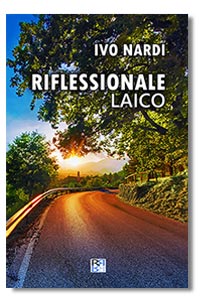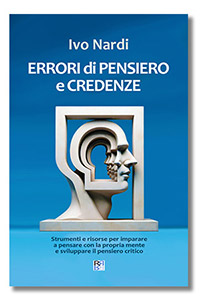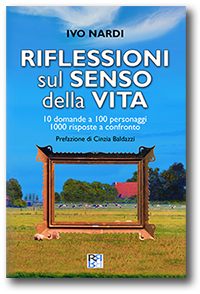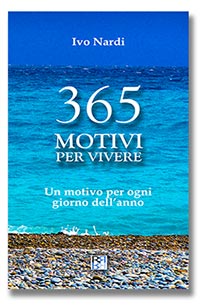Riflessioni in forma di conversazioni
di Doriano Fasoli
Interviste a personaggi della cultura italiana e straniera - Indice
Su Georges Bataille e Antonin Artaud
Conversazione con Carlo Pasi
di Doriano Fasoli per Riflessioni.it
- luglio 2005
Libri pubblicati da Riflessioni.it
RIFLESSIONI SUL SENSO DELLA VITA 365 MOTIVI PER VIVERE |
|
 Lo sguardo di Artaud, di un candore celestiale, sembra aspirato e levigato dalla luce e la limpidezza della sua espressione è scavata da un obiettivo che ha come cancellato l'ossatura dei lineamenti, le angolature, le penombre. Lo stesso Artaud era molto soddisfatto di tale interpretazione ed espresse parole di gratitudine nei confronti di Dreyer: "Ho trovato in Dreyer un uomo esigente, non soltanto un regista ma un uomo nel senso più sensibile, più umano, più completo di tale parola".
Lo sguardo di Artaud, di un candore celestiale, sembra aspirato e levigato dalla luce e la limpidezza della sua espressione è scavata da un obiettivo che ha come cancellato l'ossatura dei lineamenti, le angolature, le penombre. Lo stesso Artaud era molto soddisfatto di tale interpretazione ed espresse parole di gratitudine nei confronti di Dreyer: "Ho trovato in Dreyer un uomo esigente, non soltanto un regista ma un uomo nel senso più sensibile, più umano, più completo di tale parola".