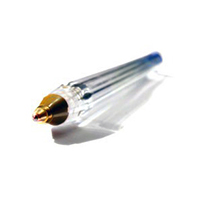
Esperienze di vita Indice
Autobiografia e il mito comunista
di Ezio Falcomer
Gent.mo Dott. Pansa,
mi permetto di inviarle una serie di riflessioni e sensazioni a caldo dopo la lettura di La grande bugia. (N.d.r. La grande bugia. La sinistra italiana e il sangue dei vinti di Giampaolo Pansa - Sperling & Kupfer, 2006)
Mi chiamo Ezio Falcomer, classe 1962, abito a Torino, sono insegnante di Italiano.
Premetto che La grande bugia è, dopo Il malloppo, solo il suo secondo libro che ho letto.
Particolarmente negli anni ’80 e primi 90’, se ricordo, i suoi articoli, soprattutto quelli su Repubblica, mi appassionavano e divertivano molto per il taglio e lo stile con cui lei descriveva la situazione politica (un esempio fra tutti il congresso della Dc del 1989: la defenestrazione di De Mita, il nascente CAF, le mitiche “truppe cammellate” irpine, andreottiane ecc.).
La lettura di La grande bugia ha risvegliato in me un cortocircuito di memoria vissuta personale e collettiva. Devo confessarle che, al di là dell’ argomento principale, la storia delle reazioni ai suoi precedenti libri sulla Resistenza, man mano che leggevo il libro, ha rievocato la psicologia comunista nella quale sono cresciuto, tra fine dell’infanzia e prima adolescenza. Un mondo di emigrati veneti, provenienti dalla miseria e dalla fame della campagna della provincia di Venezia, e insediatisi in un comune industrializzato della cintura di Torino. Della serie, le piccole Stalingrado, con giunta rigorosamente comunista e socialista, e con egemonia culturale del PCI e della FGCI. Da non trascurare il gruppo parrocchiale che conviveva e in parte si fondeva con quel mondo.
Un mondo dove si mescolavano figure di mamme e di nonne devote e tendenti a votare democristiano e figure maschili di padri e zii comunisti ortodossi, che bevevano, fumavano e bestemmiavano; e che vedevano l’URSS e l’Est comunista come un sistema superiore e migliore degli USA (in ogni caso e comunque: anche se con Stalin sarà successo quel che sarà successo, in Russia tutti hanno un titolo di studio, un sistema di assistenza eccezionale, chi non lavora non mangia, hanno una casa, padroni non ce ne sono ecc.). Naturalmente schematizzo un po’. Le faccio un esempio, tra il serio e il faceto. Mondiali di calcio del ’74, in Germania Ovest. Al girone prima degli Ottavi, si trovano di fronte le due Germanie. Seguo la partita con un mio zio, principale mentore politico. Naturalmente si tifa Germania Est. Vince la Germania Est per 1-0. Grande festa in casa.
Fino alla fine della scuola media mi sono formato politicamente su avide letture di tutto ciò che riguardasse il comunismo, la rivoluzione dall’Ottobre in poi. Il Partito comunista costituiva per me un mito. L’ascolto di “Bandiera rossa”, da bambino, mi provocava i brividi (ricordo la radio, in casa del nonno paterno, spesso sintonizzata su Radio Capodistria).
E dunque le biografie di Lenin, Stalin, Mao. Il Manifesto del Partito Comunista. Tutte le notizie che potevo carpire sulle vicende politiche mondiali, dove ci fossero situazioni di “lotta rivoluzionaria”: Cuba, il Che, il Vietnam, la caduta di Saigon, il Cile, il Medio Oriente. Tutte notizie che assorbivo da quotidiani comunisti, soprattutto “L’Unità”, con relativo taglio interpretativo. E, almeno fino al 1975, i toni della polemica politica interna/estera avevano, ricordo, un che di martellante, su parole d’ordine e indirizzi d’opinione ben precisi e memorizzabili. L’imperialismo americano, lo shock petrolifero, la responsabilità del quale andava cercata solo nelle trame delle multinazionali (le “sette sorelle”), la manus longa ossessionante della CIA a livello planetario, il boia Nixon e il diabolico Kissinger. Nella politica interna, la stigmatizzazione delle tendenze neocentriste della DC, il clerico-fascismo, la strategia della tensione, con un senso di stato d’assedio. Tutto questo, mentre, sempre nella stampa comunista (parlo sempre e solo del PCI) si faceva largo, idea ancora per me arcana e non del tutto comprensibile, la linea del compromesso storico: “grande accordo fra comunisti, socialisti, cattolici per la pace, la democrazia, il socialismo (!)”, come recitava uno striscione di un festa de “l’Unità”, nell’estate 1974.
Il 15 luglio 1975, con il PCI schizzato al 33%, mi investì (ci investì, me e i coetanei) come una scarica tra il bacchico e il palingenetico. Ricordo che seguivamo ora per ora il Consiglio nazionale della DC che scaricava Fanfani e portava alla segreteria la faccia bonaria, sofferente, pensosa e tranquillizzante di Zaccagnini.
A che punto erano, fino a quel momento, le mie nozioni e idee sulla Resistenza?
Riassumerei in modo molto breve. Erano il frutto di una formazione ricevuta, ma anche di un’autoformazione, che aveva più l’aspetto di una catechesi. Diciamo che solo ora posso osservare questo aspetto. E credo di avere avuto questa visuale, quasi automatica ed epidermica, a lungo: almeno, credo per tutti gli anni 80’. Ciò che ha iniziato a farmi cambiare questa visione è il frutto di un lento accumularsi di notizie, lette o recepite direttamente, che riguardavano tutto quello che, soprattutto negli anni 70’, sarebbe stato considerato eresia.
Non sto a dilungarmi sul come e cosa. Lei, Dottor Pansa, lo descrive magnificamente.
Posso solo dire che quelli che mi hanno, da ragazzo, parlato di Resistenza come esperienza vissuta, sono sempre stati, in maggioranza, persone che militavano o simpatizzavano per il PCI. E un ex-partigiano dell’Anpi, un sindacalista della CGIL, un militante del Partito ecc. impostavano la rappresentazione storica su un piano profondamente manicheo. Non ho mai sentito parlare, in quegli anni, di “porcate” se non relative ai tedeschi o ai repubblichini. E per me la cosa era assolutamente naturale. Il partigiano era sempre un eroe senza macchia, quello di Fischia il vento e di Bella ciao. A 13-14 anni, credo, mi era difficile pensare anche ai partigiani non comunisti. So che vi erano stati. Ma forse li sentivo come di serie B.
Il primo che mi ha dato una rappresentazione smitizzante è stato, proprio in quei tempi, mio padre. Operaio, sì, ma edile; dunque poco organico a movimenti sindacali e politici; molto lavoro a cottimo, molto nero, molti anni senza contributi. I sindacalisti erano quelli che arrivavavano all’improvviso e dicevano “oggi sciopero”, senza comitati di discussione e di lotta. Comunista fin da ragazzo, aveva maturato poi una visione della vita e della politica, diciamo fra il ’65 e il ’75 molto cruda ma anche molto meno ingenua della mia (anche se qualche volta si lasciava andare a ricordi viscerali tipo: eh, quella volta che Nenni ha fatto quella cazzata! – con riferimento al passaggio dall’unità d’azione col PCI all’ingresso nel centrosinistra).
Mio padre (nel ’43-’45, aveva 10-13 anni) esprimeva a suo modo la visione e l’esperienza della Resistenza, con linguaggi estranei alla mia acculturazione ideologica e che erano fonte di conflitti tra me e lui. “Ma chi credi che fossero sti partigiani?”. E mi raccontava di gente che si dava alla macchia perché aveva problemi coi carabinieri del paese (per semplici motivi di furto di galline o simili) o perché si era fatto la donna di un altro e sfuggiva alla prevedibile resa dei conti. Mi raccontava di famiglie contadine, meno povere della nostra, che “subivano” la visita, a quanto pare molto poco gradita, dei partigiani in cerca di vettovaglie. E si sa che se ti arrivano i partigiani, poi rischi la visita dei tedeschi. Mi raccontava delle ragazze ammazzate perché erano state fidanzate con un fascista. Ultimamente, quando ho tirato di nuovo fuori queste storie, mentre stavo leggendo La grande bugia, parlandogli degli omicidi compiuti da ex (a quel punto) partigiani a guerra finita, dal maggio ’45 in poi, lui mi ha confermato, sempre sul piano di quello che si veniva a sapere nei primi anni del dopoguerra, di episodi avvenuti nelle “zone di fuoco” (sono sue parole). E mi ha citato vari luoghi, dentro e fuori la provincia di Venezia.
Ora, Dottor Pansa, io potrei finirla qui. E se è arrivato a leggere fino a qui, non la vorrei costringere a proseguire.
Ma, all’inizio di questa lettera, le avevo confessato che la sua testimonianza di storico (e non romanziere!) della Resistenza è stato un detonatore di ricordi-riflessioni sulla psicologia e la forma mentis del comunista, di cui ne La grande bugia lei tratta ampiamente. Ricordi e riflessioni che mi hanno accompagnato da almeno un quarto di secolo: il tempo, lungo, di una fuoriuscita da una chiesa alla quale mi sentivo di appartenere. La chiesa comunista, sulla quale ho progressivamente esercitato uno sguardo, diciamo, laico-illuminista.
Nel giugno ’75 mi sentivo pienamente e naturalmente comunista. Alla fine del ’78, credo di avere, anche confusamente, iniziato la fuoriuscita.
Cos’era successo nel frattempo?
Semplicemente, al Ginnasio, ho vissuto molto da vicino ciò che è successo fra il 1976 e il 1978. Non sono mai stato un vero militante; me lo impediva un forte individualismo e un’ostilità, o disagio, quasi anarchico nei confronti di qualsiasi istituzione gerarchica organizzata. Ma sono stato pienamente partecipe, e consenziente, a quell’area politica che si riconosceva in Democrazia Proletaria. Fra il 20 giugno ’76 e la nascita del governo delle “astensioni” è avvenuto lo spostamento dal PCI all’area di DP.
Mi ricordo che il primo corteo a Torino cui ho partecipato, autunno ’76, era diviso in settori. In testa, la FGIC. In mezzo, dove stavo io, l’area DP. Dietro, non ancora violentemente esuberanti, quelli di Autonomia operaia. Uno dei primi slogan che abbiamo intonato era un parodistico “Su, su, su, le lotte vanno su, governi PCI non ne vogliamo più”. Cosa presa molto male dai compagni della FGCI.
Nella memoria, l’atto di inizio delle vere ostilità tra il PCI e ciò che si muoveva alla sua sinistra, io lo vedo nell’episodio dell’intervento di Vittorio Lama alla Sapienza di Roma e nello scontro fra servizio d’ordine del PCI e Autonomia. Febbraio-marzo del’77. Quella mattina, quando arrivò la notizia al Liceo (ma come arrivavano così in fretta le notizie senza i telefonini?), ci proiettammo tutti fuori: autoconvocazione dell’assemblea.
Quello che è successo in quell’anno non credo sia necessario narrarlo per disteso. Fu un’escalation, dove lo scontro violento di piazza e le varie forme di lotta armata presero uno spazio sempre più preponderante. Non ho mai praticato violenza, non ho mai tirato molotov, non mi sono mescolato ad Autonomia. Quelli, dovendo fare un paragone, erano dei veri e propri pasdaran della rivoluzione.
Però partecipavo pienamente di quel clima dove le azioni delle BR e di Prima Linea erano giudicate criticamente ma con un senso di forte contiguità: “Compagni che sbagliano”. E comunque “né con lo Stato né con le BR”. E comunque “lo Stato borghese si abbatte e non si cambia” (ma Lenin non diceva che lo Stato bisogna prima prenderlo e controllarlo per poi farlo morire?).
L’anno scolastico successivo, 77-78, ricordo che la vita assembleare mi procurava sempre più un disagio psicofisico che arrivava alla nausea e all’ansia. Tutti si parlavano addosso. C’era un clima di isteria collettiva. E tutti quei gambizzati e morti ammazzati da Prima Linea. So che il sentimento predominante era di una forte angoscia.
Il punto culmine, in cui l’ultima ondata postsessantotto doveva iniziare a prendere la lenta china discendente, il “riflusso” (il personale che diventa politico, lo scivolamento verso atteggiamenti e posizioni irrazionalistiche, “creative”, “desideranti”, magari autodistruttive), fu il rapimento di Moro. Eppure, confesso, che quella mattina, quando arrivò la notizia, nei corridoi, ci fu un boato da stadio (“Cazzo, ce l’hanno fatta!”)
Quando, nell’ estate-autunno ’78, Craxi provocò Berlinguer sulla questione del leninismo, alla difesa d’ufficio che Berlinguer fece di Lenin e del “centralismo democratico”, avvertii una forte insofferenza nei confronti di Berlinguer. Ma non più “da sinistra”. Semplicemente, quello che disse Berlinguer lo vedevo come qualcosa di ormai superato.
L’ultima cosa veramente originale che ritengo Berlinguer abbia fatto sia la dichiarazione dell’81 dopo il golpe di Jaruzelski in Polonia: “La rivoluzione d’Ottobre ha esaurito la sua spinta propulsiva”. Più che di coraggio nei confronti del partito penso che si sia trattato di un atto di coraggio di fronte a se stesso. Io intanto rileggevo i sacri testi, soprattutto Stato e rivoluzione di Lenin. E intanto frequentavo testi freudiani, junghiani, lacaniani, Foucault, Derrida, Deleuze, e mettiamoci anche Nietzche. Ero abituato a titoli come: Psicopatologia del partito Stato, l’esperienza della dissidenza, la psichiatria sovietica come arma di repressione politica, le purghe staliniane e le analisi comparative con i fenomeni storici del Terrore, dall’Inquisizione alla dittatura giacobina. E riuscire a metabolizzare il milione e più di morti nella Cambogia di Pol Pot.
Non ho più svolto attività di partecipazione, anche passiva, alla politica.
Confesso che se c’era un partito a cui mi sentivo vicino, negli anni ’80, era il cosiddetto “partito di Repubblica”.
Lascio tutto quello che è successo dall’89 in poi.
Diciamo che, quelle poche volte che ho votato, mi sono aggirato dal PCI al PRI. Mi considero un potenziale elettore del centrosinistra, ma dai gusti molto difficili.
Arrivo ad oggi. Come fa un comunista oggi a definirsi tale. Su quale base?
Lascio perdere i comunisti di Diliberto e Rizzo. Dovrebbero avere lo statuto di beni culturali da preservare. Soggetti di interessanti studi paleoantropologici.
Ho riletto questi giorni molte cose sulla Rivoluzione d’ottobre e, ancora, sulla nascita della corrente bolscevica del POSDR. Ho voracemente scorso, di Lenin, Che fare?, le Tesi d’Aprile, Stato e rivoluzione.
E poi mi sono imbattuto in alcuni passaggi del Documento nr. 1, mozione che ha consentito alla corrente di Bertinotti di vincere l’ultimo congresso di Rifondazione (2005?). Ho shakerato il tutto.
Riporto il passaggio più interessante
VI Congresso di Rifondazione comunista, documento 1 “alternativa di società”, Bertinotti. 15 tesi: punto 6.
6. Il grande e terribile 900 ha visto realizzarsi attraverso la lotta di classe l’ingresso delle masse nella politica e, in questo corso, si sono prodotte grandi esperienze di emancipazione, le più grandi fino ad ora conosciute. Contemporaneamente, però, il 900 è stato il secolo in cui si sono consumate tragedie inenarrabili (le guerre mondiali, i fascismi e i nazismi fino all’orrore di Auschwitz). Il movimento operaio è stato il grande protagonista del secolo ma è stato sconfitto in primo luogo per il fallimento laddove si è costituito in stato nelle società post-rivoluzionarie nelle quali le istanze di liberazione per cui era nato si sono anche rovesciate in forme di oppressione drammatica. La critica allo stalinismo non è, quindi, semplicemente la critica alle degenerazioni di quei sistemi ma al nucleo duro che ha determinato quell’esito ed è per questo motivo il punto irrinunciabile per la costruzione di una nuova idea del comunismo e del modo di costruirlo. Ora, le esperienze di movimento, le nuove pratiche sociali e le riflessioni che sono avanzate con esse consentono la costruzione di una critica al potere, che, anche attraverso la scelta della nonviolenza come guida dell’agire collettivo qui ed ora, contribuisce alla ricerca di una nuova idea e pratica della politica come processo attuale di trasformazione e di liberazione. È così venuta all’ordine del giorno la possibilità di una uscita da sinistra dalla sconfitta del 900 e dalla crisi del movimento operaio. Si può lavorare allora alla costruzione di un nuovo movimento operaio. La rifondazione comunista, orizzonte della nostra ricerca e sperimentazione, trova in questa sfida la sua ragione.
Osservazioni.
- La lotta di classe, con le masse in politica, è la più grande esperienza di emancipazione del Novecento? Sicuri?
- Le “tragedie inenarrabili” del ‘900: come al solito, solo il nazismo e il fascismo!
- Il “movimento operaio” non si è costituito mai in stato. Lo ha fatto, per esso, un’organizzazione sedicente “avanguardia politica e intellettuale” del proletariato. Organizzazione trasformatasi in classe dominante di burocrati e funzionari del posto fisso = nomenklatura.
- La “degenerazione” avviene solo con lo stalinismo? È lo stalinismo il “nucleo duro” della “degenerazione” autoritaria dello stato nato dalla lotta rivoluzionaria del proletariato?
- La mia risposta è no. La tragedia, allo stato larvale, nasce con la costituzione, da parte di Lenin del partito bolscevico. Organizzazione dei “professionisti della rivoluzione”. Essi, in quanto teologi messianici atei, portatori di una verità scientifica, e dunque, in senso positivistico, assoluta, si proclamano guida delle masse operaie altrimenti spinte a forme di lotta spontaneistiche e “economiciste”.
Lenin critica la pretesa dei socialisti riformisti alla “libertà di critica della dottrina marxista ortodossa”, dicendo che questa “libertà di critica” contiene solo l’assenza di ogni critica veramente marxista. La democrazia, per Lenin, fin dall’inizio è una forma, la più raffinata, di predominio di classe della borghesia. In quanto tale, la democrazia è destinata alla soppressione in nome della vera”democrazia”: la dittatura armata del proletariato e l’esercizio della repressione nei confronti della classe avversaria.
Detto questo, ancora qualche ultima considerazione.
- Io ritengo che qualsiasi atto politico finalizzato a dare la felicità alla società umana sia, di per sé, profondamente sospetto. Esso è figlio dell’utopica e ingenua teoria illuminista della “pubblica felicità” . Parlare di felicità stabile nella realtà umana è qualcosa di folle. Ogni realtà umana ha i caratteri della non permanenza di ogni cosa.
- L’atto politico più pragmatico ed efficace consiste nell’estensione maggiore possibile dello stato di diritto, della convivenza delle diversità, nella risoluzione e mediazione dei conflitti attraverso il legittimo monopolio della forza, monopolio giuridicamente controllato e definito da contropoteri altrettanto forti.
- Penso che la rivoluzione più grande della storia moderna e contemporanea sia l’introduzione, nel 1679 in Inghilterra, dell’Habeas Corpus Act, poi recepito nell’articolo 9 della Dichiarazione ONU dei diritti umani. Diritto dell’individuo a conoscere i motivi di un’eventuale limitazione della libertà personale da parte del potere esecutivo, e diritto dell’individuo stesso a comparire davanti a un esponente del potere giudiziario per difendersi dall’accusa.
Ezio Falcomer - febbraio 2007
Il libro:
La grande bugia. La sinistra italiana e il sangue dei vinti
di Giampaolo Pansa - Sperling & Kupfer, 2006.
Descrizione: Un titolo volutamene provocatorio per un libro in cui Giampaolo Pansa non risparmia nulla a quanti hanno criticato la sua ricostruzione degli anni immediatamente successivi alla Liberazione. Le storie, vere, raccontate nei suoi due precedenti best-seller, storie che volevano dare voce anche agli sconfitti e a quanti avevano subito vendette da parte dei vincitori, hanno infatti scatenato aspri commenti e giudizi contro Pansa da parte di storici, politici, giornalisti e cittadini schierati a sinistra e indignati per quella che hanno ritenuto un'inammissibile opera di "revisione" (e quindi denigrazione) della Resistenza. La risposta dell'autore a tale offensiva è in quest'opera, in cui la "grande bugia" costruita dalla sinistra contro chi volesse far luce con onestà e rigore anche sugli eventi meno nobili della guerra civile, viene smantellata e analizzata con puntiglio e lucidità. Fonte www.lafeltrinelli.it
Libri pubblicati da Riflessioni.it
RIFLESSIONI SUL SENSO DELLA VITA 365 MOTIVI PER VIVERE |



